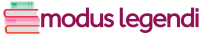Ho bisogno di immagini, sulle quali riconosco i miei stati d’animo quasi con altrettanta prontezza e precisione che sugli scritti di un autore. […] Il mio mondo è stipato di figure.
Emilio Cecchi è uno degli autori che si inserisce perfettamente in quel filone di scrittori che, dopo il pieno sviluppo della fotografia, ne sono rimasti turbati, di quel turbamento che dà emozioni intensissime. Ecco infatti che in uno dei suoi libri più brillanti, Messico, l’idea di fotografia fumosa che congela l’ombra del soggetto per sempre, che vivifica lo spettro o mortifera il vivo, è assai presente – accanto alle magnifiche descrizioni che altro non sono che fotografie in parola. Questo viaggio verso il cuore centroamericano, verso il Messico, sembra quasi essere un viaggio dalla storia recente, rappresentata dagli States, al mondo pre-storico messicano, dalla società dei vincitori a quella dei vinti. Tutto il libro è percorso da questa dialettica: dalle luci splendenti di Hollywood alla nera notte messicana. E ombra e luce sono appunto due aspetti primari, fondamentali della fotografia: se non ci fosse la luce non si potrebbe catturare l’immagine e senza l’ombra non la si potrebbe sviluppare. E queste fotografie che vengono sempre menzionate, fino ad arrivare al culmine nel capitolo intitolato – non a caso – Fotografie della rivoluzione, rimandano sempre a qualcosa di fantasmatico; eccoci infatti davanti alle descrizioni delle ghost town americane le quali, con i loro ricordi in bella vista, richiamano alla mente di Cecchi, e del lettore, immagini di un mondo passato. Di morte e di assenza sono piene le pagine dedicate alle città fantasma, nei luoghi delle miniere d’oro ormai abbandonate, dove la natura si riappropria del territorio. Quelle che un tempo erano città piene di vita, ora sono immobili monoliti di ciarpame che si degradano sotto il sole californiano, con i saloon ancora in bella vista. Ma è nel cuore dei paesi a ridosso del Messico che si mostra tutto l’essere spettrale degli Stati Uniti. Il sovrannaturale e lo spettrale popolano queste pagine, creando meravigliose descrizioni di particolari lontanissimi, come se Cecchi utilizzasse la tecnica dello zoom servendosi soltanto delle parole. E lo vediamo aggirarsi tra i villaggi Navajo e i manufatti indigeni, i quali «come le antiche pitture cinesi, di preferenza esse raffigurano divinità, spettri, mediatori fra la Natura e il sovrannaturale, gerarchie ermetiche». Tra queste arcaiche raffigurazioni spettrali, vi sono anche bellissimi tessuti fatti a mano dalle donne Navajo, le quali inseriscono nella trama una frattura, un errore: lo spirito delle tessitrici, così, non rimarrà ingabbiato all’interno del tessuto. Questo quia imperfectum rimanda in qualche maniera alla credenza che anche le fotografie possano carpire l’anima del fotografato, per cristallizzarla in eterno.
E colui o ciò che è fotografato, è il bersaglio, il referente, sorta di piccolo simulacro, di eidolon emesso dall’oggetto, che io chiamerei volentieri lo Spectrum.
E l’eidolon non è altro che l’essenza di ogni uomo e di ogni cosa.
Giunto a metà del viaggio, Cecchi si ritrova in un mondo diverso che, per quanto toccato dalla modernità post rivoluzionaria, sembra ancora il mondo dei sacrifici di sangue e degli idoli di legno. La monumentalità è la cosa più importante in queste ultime pagine messicane, perché l’essenza degli abitanti dello stato centroamericano è proprio quella di essere monolitici, imperituri come le grandi piramidi azteche che combattono contro l’erosione del tempo. Troviamo la vastità e la potenza dell’immaginario precolombiano; tutto si tinge di maestosità triste, quasi mortifera, perché è questo il Messico reale: è decadente, austero nel suo sfacelo, a primo acchito arido ma strenuamente feroce e orgoglioso, anche nei luoghi più impensabili. Quel che Cecchi ci mostra subito dopo è la particolare forma di cattolicesimo che si è diffusa in Messico; la sua «furia profonda» si riversa anche nella religiosità.
Le parole cecchiane descrivono la scena come se la si guardasse attraverso una fotografia, o ancor meglio come se si guardasse un fotografo scattare una foto con una delle antiche macchine fotografiche.
La chiesa era piena da non entrarci. E sopra il mare delle teste si vedeva, lontanissimo, in una luce di magnesio, l’altare fluttuante di veli bianchi.
L’altra faccia della medaglia, però, è l’antica religione precolombiana: giunto alle maestose piramidi Cecchi si lascia trasportare da tutto quello che vede e ci racconta di una religione le cui radici si sono perse nella notte dei tempi, feroce e sanguinosa. Quel che più sgomenta Cecchi, che lo lascia esterrefatto, è la violenza esplicita delle religioni mesoamericane: il dio Sole è dio della fecondità e della Morte. In un intricato groviglio di sangue e demoniaco, le spire del serpente – simbolo emblematico di quella fede – è come se si stringessero sempre più e svelassero la loro verità: «il serpente, l’animale apparentemente più rudimentale (senza arti, senza pelame, senza sangue caldo), rappresenta l’origine (ctonia) e l’indifferenziazione (notturna), l’assenza d’ordine cosmico, la libido senza legge». Emerge l’essenza mortifera delle religioni messicane, tanto che «anche il demonio è collaboratore d’Iddio. Ma qui non si veggono Dei; e solamente diavoli, infamità e lutti».
La terra del serpente, questo è il Messico: una terra il cui il dio supremo (o infero) è l’essere che per i cattolici è, invece, simbolo del male, Lucifero incarnato nel serpente della tentazione all’interno dell’Eden. La perturbante presenza di una religiosità così animalesca rimane sempre latente, quasi in un «simbolo di fecondità ma anche di lussuria».
Entrando in un «teatrino settecentesco», il Principal, Cecchi ritrova – infatti – questi movimenti serpentini.
A un certo punto dello spettacolo, il velario s’aprì sopra un bassorilievo di membra ignude che riempiva il proscenio: una parete di corpi intrecciati che la luce dei riflettori imperlava di sudore fosforico; una apoteosi di idoli impudichi e solenni.
Sempre presente il richiamo fotografico, l’intreccio dei corpi ricorda le spire di un serpente, in un continuo ritorno verso il mondo ctonio, segreto, misterioso. Una religiosità che si fa carne, che ha ancora qualcosa del sacro ma è contaminata dal profano. E tutto questo non è altro che la conferma che qualcosa di monolitico, in questa religione solo apparentemente dimenticata ma in effetti assorbita e ben evidente ancora nel cattolicesimo centroamericano, rimane sempre. Infine si giunge a quello che può essere considerato il fulcro di Messico, i capitoli dedicati alle fotografie e alla rivoluzione messicana.
Ritorna l’opposizione tra la cruda realtà del Messico visibile attraverso le fotografie, in cui la rivoluzione «ha un volto straordinariamente umano, vorrei dire quasi classico» e la rappresentazione che di essa ha dato Hollywood, con la sua spettacolarizzazione, il suo ritocco della realtà:
Ma ciò che conta sono le scene e figure militari e popolari; e bastano quelle che si animano intorno a Villa e Zapata per farci deplorare, ancora una volta, il trattamento che dalla cinematografia americana, e purtroppo (con opposte intenzioni) da Eisenstein, fu fatto d’una materia sì schietta.
Alla fine del capitolo, Cecchi ci lascia un’ultima descrizione di una fotografia: Villa e Zapata messi in posa, una posa ridanciana, vicino al «trono “presidenziale”». Lo scatto di un ignoto fotografo ha catturato per sempre il momento, e gli eroi sono già morti, spettri fotografati.
Tra riti luttuosi, maschere, granitiche figure e fotografie, si conclude il viaggio di Cecchi. Un mondo ctonio e vibrante, avvolto da una nebbia fosforica, reale nella sua crudezza, non paragonabile agli artificiosi Stati Uniti; il tempo in Messico è quasi sospeso, in cui antico e moderno, indigeno e cristiano, convivono in uno scatto, in un momento che dura, forse, per sempre.
La vita del Messico s’intesse tutta d’un principio elementare, d’un ritmo lento e violento. […] Non saprei darne idea che pensando a un senso del tempo diverso da quello che si ha in qualsiasi altro paese. Non un tempo astratto e inaccessibile, come sull’oceano o in un’antica foresta, dove quasi si crede di sorprender la natura ignara ed intatta dentro ai propri confini. Non il tempo geologico delle montagne. E tuttavia, un tempo incredibilmente austero e crudele; dentro al quale, le pietre azteche, gli ori cattolici e le figure d’oggi esistono in assoluta contemporaneità e indifferenza.