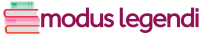Osservo incantato il paesaggio che mi si svolge davanti agli occhi, i boschi fitti di betulle, la vastità dei campi innevati nel crepuscolo, l’apparente danza ritmica dei pali del telegrafo sbilenchi, il su e giù continuo del cavo che li unisce, l’occasionale casa fatiscente e il rosso sbiadito degli striscioni che inneggiano alla costruzione del socialismo.
È il tardo autunno del 1989, sono uno studente di russo in scambio a Mosca e mi trovo sul treno che dalla stazione Belorusskij della capitale macinerà stancamente centinaia e centinaia di chilometri nel freddo della notte fino a Vilnius, nella repubblica ancora per poco sovietica della Lituania, dove mi attendono alcuni amici.
La porta si apre e senza tanti complimenti l’energica cuccettista deposita sul tavolino un vassoio con quattro bicchieri di tè scuro fumante nel caratteristico supporto di metallo, mentre lo scompartimento è invaso d’un tratto dall’odore acre del carbone usato per riscaldare il samovar. Uno dei passeggeri abbassa il libro che sta leggendo e senza chiuderlo lo appoggia a faccia in giù sulle ginocchia.
Interrompo a questo punto la pellicola cinemnemonica dei miei ricordi giovanili, ahimè, lontani, ma sempre vividi, per soffermarmi su un dettaglio di quel gesto naturale del passeggero. Si sa, una delle caratteristiche del lettore incallito è la curiosità che lo spinge a ficcare il naso – o lo sguardo, in tal caso – nelle letture altrui. Vi sarà capitato di viaggiare o trovarvi in una sala d’attesa e morire dalla voglia di sapere che cosa starà mai leggendo la signora seduta più in là. Tiene le mani sulla copertina o, peggio, ha ripiegato un lato del volume sotto l’altro e vi rende impossibile distinguere il titolo. Magari riconoscete la veste grafica della casa editrice, ma proprio non c’è verso di riuscire a risolvere l’arcano. Vi spingete fino a lasciar cadere una penna per terra e vi chinate a raccoglierla nella speranza di scorgere qualche indizio da una diversa angolazione, ma niente da fare.
Nella scena che ho descritto sopra ricordo di essere stato mosso dalla stessa curiosità, una curiosità amplificata dalla consapevolezza di non trovarmi su un tram di Milano o nella saletta piena di riviste del dentista, ma su un treno sovietico in compagnia di passeggeri sovietici. Avrei potuto semplicemente sbirciare dal mio posto la copertina tenuta in bella mostra sul grembo dello sconosciuto, si potrebbe pensare, se non fosse che questa era foderata dalle pagine della Pravda, il quotidiano ufficiale del PCUS, e pertanto appariva anonima.
Erano ormai gli sgoccioli dell’impero sovietico, avviato verso l’imminente sgretolamento, perciò è plausibile ritenere che dopotutto anche la carta dell’organo di stampa del partito potesse trovare maggiore utilità in applicazioni diverse dalla funzione originale di mezzo di informazione. Ma il motivo del rivestimento fai-da-te in uso tra i lettori russi, che presto cominciai ad adottare anch’io, sebbene nel mio caso si trattasse più di un ghiribizzo, di una sorta di simpatica emulazione, era un altro.
Ai tempi dell’Unione Sovietica, nel periodo post-staliniano – perché in quello staliniano le autorità adottavano metodi di convincimento, diciamo così, più diretti – le case editrici ufficiali stampavano letteratura di regime noiosa, innocua e anestetizzante o che esaltava in modo più o meno velato i valori del comunismo e la società sovietica. Entravi in una delle tante librerie, fornitissime di volumi e frequentatissime da persone di tutte le età, rovistavi per un po’ nella speranza di trovare qualche lettura decente e ne uscivi perlopiù a mani vuote. I libri che andavano a ruba erano ben altri, erano quelli stampati dall’editoria clandestina (“samizdat” per gli autori russi e “tamizdat” per gli stranieri) o anche solo trascritti a mano da lettori volenterosi o trafugati dall’estero, dei vari Pasternak, Grossman, Šalamov, Dovlatov, Brodskij, Erofeev, tanto per citarne solo alcuni, perché erano le opere degli scrittori veri, che andavano a rimestare nella melma e scavavano nella complessità della natura umana. Naturalmente, avere una copia di un autore inviso al regime poteva essere compromettente e dunque era consigliabile evitare di ostentarne il possesso e una delle strategie diffuse consisteva appunto nel rilegare provvisoriamente il libro interessato con carta di giornale, un modo per mantenere una sobria anonimità di lettura.
La dittatura dei soviet era ormai sul punto di sfaldarsi e le maglie della polizia segreta tra le quali erano rimasti intrappolati tanti cittadini non allineati e poco obbedienti si erano allargate già da qualche anno quando intrapresi il mio viaggio verso il Baltico. Ma la sensazione che con quel sistema di camuffamento la gente comune volesse ancora proteggere qualcosa di prezioso, qualcosa che aveva un valore inestimabile e sacro, ossia, il valore della parola e del suo significato vero, ben diverso dalla patina semantica superficiale della letteratura ufficiale, edulcorata, intrisa di ideologia o al massimo neutrale e dunque niente affatto interessante, la percepivo ancora. Non a caso ho scelto l’aggettivo “sacro”, nel senso che in Russia fin dai tempi di Puškin, in una società civile rimasta indietro rispetto al resto d’Europa, la letteratura ha sempre svolto un ruolo formativo importante, diventando uno strumento di diffusione di temi sociali, storici, filosofici o di identità nazionale, che ha finito con l’attribuire funzioni profetiche agli scrittori. Anche in era sovietica. E, aggiungerei, ancora di più in era sovietica, seppure più clandestinamente, quando la sistematica sterilizzazione di qualsiasi misticismo, espressione religiosa o altra estrinsecazione metafisica aveva invece contribuito a conferire il ruolo di martiri e testimoni a poeti e scrittori, in quanto portatori di Verità e di una forma meno controllabile di libertà di pensiero.
Riprendo la memoproiezione.
La curiosità è forte ma sono troppo giovane e timido per porre domande indiscrete a uno sconosciuto nello scompartimento di un treno che attraversa la pianura russa. Ma è proprio lui, lo sconosciuto, a venirmi incontro. Tra un sorso di tè e l’altro, durante i convenevoli viene fuori che sono italiano, tradito sicuramente dalla mia inflessione non esattamente moscovita.
“Che sublime coincidenza, sto proprio leggendo un bellissimo romanzo italiano”, solleva il volume e mi mostra il frontespizio con il titolo in caratteri cirillici.
Mi ero figurato una copia furtiva di un’opera di Solženitsyn o di Nabokov e il successivo agguato di un agente del KGB travestito da cuccettista e invece mi ritrovo al cospetto della traduzione russa autorizzata de Il nome della rosa di Umberto Eco. Ma allora la rilegatura con carta di giornale?
“Oh quella? Non volevo rischiare di rovinare la copertina di questo meraviglioso libro con ditate e macchie di ogni genere, così ho rimediato come ho potuto”.
È buio ormai fuori dal finestrino. Distinguo appena qualche ombra che scorre nel blu della notte del bassopiano sarmatico e con il sapore amaro dei residui di foglie di tè in bocca ripenso al paradosso della sacralità della scrittura, custodita con cura dalla Pravda.