Quello che a prima vista tendiamo a definire come clima letterario italiano si caratterizza per l’attitudine a epurare ciò che per definizione non è funzionale al mercato o non segue le mode. È evidente nella scelta dei temi e degli autori, nonché delle lingue in cui questi ultimi scrivono. L’ideologia commerciale fa sì che buona parte dei testi che arrivano dall’estero risponda a criteri ancorati a logore strategie di vendibilità avulse dalla promozione culturale. Questo è anche e soprattutto il destino di tutta quella letteratura tradotta dalle lingue “minoritarie”, frequentate di rado e per caso, quasi come dessero fastidio. Parenti scomodi, vestiti di seconda mano, ai quali si chiede preferibilmente di fare da tappezzeria. I temerari che si avventurano nella loro pubblicazione devono vedersela con un mercato sovradimensionato, poco attento alla qualità e prono alla lingua angloamericana. Autori come Veselin Marković, Darko Tuševljaković, Danilo Kiš, György Konrád Varlam Šalamov sono solo alcuni esponenti di una letteratura difforme, non incline a vezzeggiare i lettori ma pregna di una tradizione letteraria di primissimo livello. Per addentrarci nell’universo di quelle lingue che io ho definito “dimesse”, per non dire subalterne, ho scelto di dialogare con Anita Vuco, traduttrice dal croato e dal serbo e dall’italiano nelle due lingue. La sua è una storia singolare. È nata a Spalato, oggi vive in Italia. Il suo primo riconoscimento come traduttrice non avviene nel suo paese ma in Serbia, per l’UKPS (Udruženje Književnih Prevodilaca Srbije), l’Associazione dei traduttori editoriali della Serbia.
1) Ci puoi spiegare meglio la tua storia professionale?
Non credo che ci sia una netta separazione tra quella che può essere definita la mia ‘storia professionale’ e la mia vita. Dopo aver preso il diploma di liceo classico a Spalato, nell’anno accademico 1990/91 frequento l’università di lingue a Zara dove, presso la cattedra di Lingua e letteratura russa e quella italiana, sostengo con il massimo dei voti i nove esami previsti del primo anno. È un momento cruciale, poiché da lì a poco sarebbe iniziata la guerra. Ignara della sorte che ci sarebbe toccata, consegno la documentazione per studiare in Italia e il giorno prima della chiusura delle frontiere (che mi prende di sorpresa) arrivo a Roma. Ci sarebbe molto da raccontare riguardo quel periodo, se mai troverò un modo e il coraggio di farlo. Ammesso che sia indispensabile condividere il proprio vissuto, certe volte mi assale il dubbio che la ‘letteratura’ ben volentieri ne farebbe a meno – l’autocritica va salvaguardata. Per il momento mi limito a dire che avevo una somma di vecchie duecentocinquantamila lire in tasca, due vestiti estivi nella borsa e La figlia del capitano di Puškin, pubblicata da Branko Đonović, Belgrado 1963, in traduzione di Božidar Kovačević; un libricino miracoloso che (lo dico sorridendo) negli anni Novanta credo mi abbia salvata – non appena arrivavo all’ultima pagina, sbrigavo qualche faccenda quotidiana e ricominciavo da capo, quasi il vecchio Savél’ič fosse capace di prendersi cura anche di me. E, naturalmente, il biglietto di andata e ritorno per l’Italia rimasto inutilizzato. I soldi bastarono per assicurarmi un pasto giornaliero e cinque notti in una squallida stanza nei pressi della stazione Termini. Il sesto giorno dormii in un parco, insieme all’amica con cui ero partita, il giorno seguente riuscimmo a trovare un primo lavoro. In seguito sostenemmo l’esame d’ammissione per gli studenti stranieri, per i quali si prevedeva il numero chiuso, e lo superammo entrambe. La vita intanto galoppava veloce, esami, laurea, figli, dottorato, scandita da problemi e piccole gioie, noncurante di come ci si sente. Per fortuna potevo sempre aggrapparmi alla letteratura che nel frattempo non mi aveva mai abbandonata, o meglio, non sono stata io a uscire fuori da lei. Eppure, la coscienza di quanto fosse meraviglioso e importante tradurre quelli che considero i libri necessari e di qualità, dalle mie due lingue madre, è arrivata solo di recente, parlo degli ultimi cinque o sei anni. Avvenne a Belgrado, dove su invito dell’Associazione dei traduttori letterari serbi, avevo partecipato a Beps (Incontri internazionali belgradesi dei traduttori editoriali). Per la prima volta percepii di essere parte di un ingranaggio che trascende la mia vita. Ed è sempre grazie a Belgrado che in seguito ho riallacciato i rapporti con Zagabria, Skoplje, Bitola, Sarajevo, Fiume, Ljubljana; anche se in fondo non importa l’ordine con cui questo è avvenuto. Sono felice che sia successo, e tanto mi basta. Non è facile essere una traduttrice letteraria, un lavoro che meriterebbe un sostegno fisso dallo Stato per chiunque decida di dedicare la propria esistenza alla letteratura, l’unica in grado di nutrirci quando tutto il resto attorno a noi crolla, e a tirarci fuori vivi. Alain Cappon, meritevole di innumerevoli traduzioni dal serbo in francese, mi racconta che da studente era deciso a studiare il russo, e avrebbe probabilmente proseguito per quella strada se proprio quell’anno all’Università di Lille, a nord della Francia dove viveva all’epoca, non ci fosse stato un certo Danilo Kiš a fare da docente di Lingua serbo-croata. «Alain, quello che non sai non puoi inventarlo», gli disse Danilo nel 1989, solo un anno prima di morire, «e quello che sai l’hai tradotto bene. Quindi ti consiglio di continuare a tradurre, ma ti devo anche mettere in guardia: tradurre è una droga!»
2) La modernità ha messo in discussione le disuguaglianze ma non le ha neutralizzate e la letteratura si pone in antitesi proprio per via della funzione dello scrittore e dunque del suo traduttore. Tradurre è un’azione politica. Fino a che punto un traduttore corre dei rischi? E una traduttrice?
Tutto è un’azione politica. Persino astenersi dalla politica è un’azione politica. Scegliere un libro piuttosto che un altro è un’azione politica. Non aver voluto studiare l’inglese è un’azione politica. Aver scelto un paese in cui vivere al posto di un altro è un’azione politica. Decidere a chi dare la propria voce non può che essere un’azione politica. Così come decidere a chi non darla non lo è da meno. Scherzi a parte, un traduttore/ice non rischia nulla in più rispetto a una qualsiasi persona cosciente che grazie al proprio operato quotidiano sfugge alle logiche di un mondo unificato dal neocapitalismo, per dirla con le parole di Pasolini, ossia, da un internazionalismo creato, con la violenza, dalla necessità della produzione e del consumo. Sì, traduco per oppormi a chi ci vorrebbe vedere divisi – noi, Slavi del sud. Traduco perché non conosco un modo migliore per protestare. Traduco perché altrimenti non saprei come medicarmi. Traduco perché non ho dimenticato nulla. Traduco per sconfiggere la paura che questo sia un rischio. Traduco per sconfiggere la paura che ci possa essere impedito di ragionare. Traduco perché l’odio non può averla vinta.
3) Come è vista nel nostro paese la figura del traduttore?
Se escludiamo il mondo editoriale, perché è ovvio che qui non stiamo parlando dell’immagine che abbiamo di noi stessi, né tanto meno di quella che possano avere di noi le persone delle varie redazioni con cui collaboriamo, ma coloro che non hanno idea dei diversi passaggi che un libro subisce passando da una lingua all’altra, direi che la figura del traduttore è inesistente. Credo che questo dipenda molto dal fattore economico che quasi di regola fa scaturire il seguente ragionamento: d’accordo, traduci i libri, ma per mantenerti che lavoro fai? In qualche modo un traduttore letterario sembra essere rimasto quel figlio adolescente che non sa cosa vuole fare da grande. Se la cava bene con una o più lingue straniere e, di conseguenza, piuttosto che sprecare la giornata, si immerge nelle pagine e traduce. Forse solo i lettori più consapevoli arrivano a intuire che dietro agli autori amati c’è l’impegno di una vita. E non mi soffermerei alla sola figura del traduttore, il revisore è in una posizione ancora meno riconosciuta, sebbene la resa definitiva dipenda tanto dalla sua sensibilità e volontà di conoscere l’altro. L’ho già detto altrove e lo ripeto, il revisore è la mia coscienza, un essere di cui mi devo fidare. Voglio osare, voglio spingermi ai limiti convenzionali di una lingua, e lui/ lei dev’essere affascinato dalle stesse possibilità che il linguaggio ci offre, riprendendomi solo nei casi estremi, quando si rischia di creare qualcosa di ingestibile, non prima.
4) In Italia ci sono ancora delle differenze sostanziali nell’impiego di una traduttrice rispetto a un traduttore? Se sì, quali?
Se ci fossero, non me ne sono accorta. Non mi sono mai sentita trattata diversamente rispetto agli uomini, né ho visto questo genere di disuguaglianza attorno a me. Potrei dire tutt’altro riguardo alla possibilità di emergere in quanto traduttore/ice di una lingua ‘minore’, cosa per cui molti addetti ai lavori sono convinti che sono loro a farti quasi un favore perché un testo a cui tieni veda la luce. Sì, un editore deve saper fare i conti con il mercato, non si può certo permettere la spensieratezza romantica senza badare alle spese, ma non deve diventare un volgare rivenditore di parole. Se dico editore, intendo ancora qualcuno che di letteratura si intende. La ama, la sceglie, ci tiene. In questo senso posso considerarmi fortunata, seguendo l’esempio di alcuni colleghi che vivono la traduzione da molto prima di me, ho saputo in partenza correggere i miei passi e non cedere a ricatti di questo tipo, per una come lei è già tanto se… No, una come me sa esattamente di che cosa parla quando propone un autore.
5) In Croazia e in Serbia è la stessa cosa?
A dire il vero, conosco molto meglio l’ambiente editoriale in Serbia con cui finora ho avuto più contatti, anche se immagino che le due realtà non siano molto differenti. È strano fare i paragoni. Da un lato la figura del traduttore non è maggiormente riconosciuta, anche loro lottano per gli stessi diritti di cui sentiamo la mancanza in Italia, la visibilità del loro lavoro, le recensioni che spesso omettono il nome del traduttore, le traduzioni di libri superbi che cadono nel dimenticatoio il giorno dopo che sono state pubblicate, la previdenza sociale, la puntualità dei pagamenti, per non parlare dell’importo a cartella decisamente troppo basso, spesso vergognoso, in un sistema che si immagina i traduttori letterari come una specie di macchine che ingoiano i testi per sputarli belli e pronti nel giro di poco tempo, senza fermare mai la produzione, no, quella non deve patire. D’altro canto, per assurdo, proprio lì conosco tantissimi traduttori letterari che in vita loro non hanno fatto né stanno facendo altri lavori per mantenersi, ma vivono di sola traduzione. Un’utopia da queste parti.
6) Secondo te cosa si aspetta il lettore tipo da una traduzione?
Che non ‘fatichi’ a leggere, il che significa che non imparerà mai a leggere. Anche se sono del pensiero che molte persone sarebbero capaci di farlo, se solo si lasciassero andare. Qualcuno ha inculcato nelle loro teste l’idea secondo cui per riposare il cervello serve ‘staccarlo’, piuttosto che dargli maggiori stimoli. Si sono convinti che esistono le letterature ‘facili’ e quelle ‘serie’, di conseguenza tristi, cupe, poco comprensibili; nulla di più sbagliato. Bisognerebbe sorprenderli, almeno una volta. Chiunque di noi riesca a farlo, è un bene per tutti.
7) E un editore?
Esiste un certo tipo di editore che non si aspetta niente. Gli è indifferente di quale lingua si tratta, chi sia l’autore, di cosa parli, in quale modo, cosa in realtà dovrebbero trasmettere le sue parole, se si sia riusciti a renderlo in traduzione o si ha fallito, se ci sono refusi, e quant’altro. Non gli interessa niente di niente, gli piace stampare le locandine, tenere il microfono in mano e darsi le arie di uno che pubblica i libri, possibilmente strani, esotici, diversi. Per lui sei un numero, una voce da inserire nel proprio catalogo, una copertina di cui presto si scorderà. Cerco di stare alla larga da questo genere di personaggi. Prima di fare una proposta studio a chi indirizzarla, cerco chi è più adatto a me. L’obiettivo non è quello di pubblicare a tutti i costi, ma di farlo con qualcuno che saprà comprendere cos’è che ha pubblicato, e perché mai l’ha fatto. A quel punto l’editore vorrà la puntualità sulla consegna, e la traduzione più pulita possibile, come è giusto che sia. Vorrà un testo bello, particolare, ma allo stesso tempo vendibile. Vorrà una bozza che non lo farà diventare matto nella fase della revisione, cosa che si impara solo lavorando.
8) Il serbo e il croato in editoria sono lingue minoritarie. Quali elementi giocano a sfavore di un riconoscimento più esteso da parte dei lettori?
I libri scelti senza un criterio. Se traduci un libro scarso o mediocre dall’inglese, o dal francese se preferisci, non danneggi l’immagine di letteratura in quella lingua. Qualcuno lo leggerà, dirà appunto che non è poi un gran libro, ma questo non gli impedirà di avvicinarsi ad altri titoli di cui il mercato abbonda. Viceversa, la persona che prende in mano un libro in traduzione da una qualsiasi delle lingue minoritarie, con cui non ha mai prima avuto alcun contatto, e di cui sa poco o niente, grazie a quel libro giudicherà tutti gli altri libri provenienti da quell’area culturale e linguistica. Ora, ci sono molti più libri buoni, ottimi, eccellenti, quello che vogliamo, scritti però in un’ottica prettamente locale che grazie alla loro ironia, riferimenti, allusioni o altro, non significano nulla nemmeno per cittadini della provincia adiacente, figuriamoci all’estero, non degni insomma di essere tradotti, rispetto a quelli davvero rappresentativi a un livello universale più elevato. Non mi interessano i libri serbi o croati in quanto tali, è molto più probabile che non mi colpisca affatto una scrittura che provenga dalle mie terre, ma coloro che sceglierei e sentirei miei anche se fossero stati scritti in lingua ongota – e invece, per miracolo, qualcuno li ha scritti proprio nei Balcani. Se questo diventasse un criterio, come metteva in rilievo Danilo Kiš nell’intervista Značaj dobrog i odanog čitaoca [I meriti di un lettore buono e fedele], del 1983 – “tutti noi potremmo essere comprensibili per il resto del mondo, se soltanto la nostra letteratura riuscisse a presentarsi con una buona selezione, in modo comunitario, come un’entità centro europea e slava. Così come, in primo luogo, si è presentata all’Europa degli inizi del secolo, la letteratura nordica, o come poco tempo addietro fece quella sudamericana, con il suo felice esordio. Il che significa – presentando ciò che in esse vi è di meglio.”
9) Quali autori serbi e croati auspicherebbe divenissero più popolari in Italia? E perché?
Non dovrei parlare di Danilo Kiš, (edito da Adelphi, trad. Lionello Costantini/ Ljiljana Avirović/ Dunja Badnjević), i cui libri regalerei a ogni persona che incontro. Lui si presuppone, sempre. Oltre coloro che finora ho avuto la gioia di tradurre – Saša Stojanović, Vladimir Tasić, Darko Tuševljaković, Veselin Marković, Miroslav Krleža, Mihajlo Pantić – e per i quali spero ci sarà un seguito, la mia prima scelta sarebbero senz’altro Vida Ognjenović, Janko Polić Kamov, Daša Drndić (edita da Bompiani, trad. Ljiljana Avirović), Zoran Žmirić, Darko Cvijetić, Maruša Krese (edita da Besa, trad. Lucia Gaja Scuteri), David Albahari (edito da Hefti/ Besa/ Einaudi/ Zandonai, trad. Silvio Ferrari/ Augusto Fonseca/ Alice Parmeggiani), Laslo Blašković, Tea Tulić (edita da Mincione edizioni, trad. Federico Giulio Sicurella), Dimitar Baševski, Jani Virk, Goran Petrović (edito da Ponte Alle Grazie, trad. Dunja Badnjević), Srđan Valjarević, Gojko Božović, Branislav Petrović, Ivana Dimić, David Mladinov, Dragi Mihajlovski mescolando tra diverse generazioni, generi e aree di provenienza (non chiedermi chi tra loro sia croato, serbo, sloveno, bosniaco o macedone, è un’ottica che non mi appartiene), per il motivo più semplice che ci possa essere: sanno come toccarti con le parole e, allo stesso tempo, sono brave persone. Le due cose devono andare a braccetto, etica ed estetica devono coesistere. Sicuramente ce ne sono altri, sono solo io a essere ancora ignorante.
10) Su dieci libri tradotti in Italia da altre lingue almeno sei sono di provenienza angloamericana. Perché? Chi decide?
La battaglia per il libro si svolge sui banchi di scuola, in quella tenera età quando sembra così improbabile che un bambino possa decidere sul futuro del mondo. Dipende dai suoi professori, dalle loro preferenze (non parlo qui dei programmi scolastici, ma di quei libri per cui viene suggerito di leggere a libera scelta). Potrà mai un adulto cresciuto con i modelli anglosassoni chiedere ai propri allievi di leggere un autore albanese, marocchino, serbo, turco, ungherese? E perché dovrebbe? Non li conosce, di conseguenza, non esistono. E quello stesso bambino, crescendo, potrà mai appassionarsi davvero a una qualsiasi delle lingue e letterature ‘minori’? Indispensabili invece per la biodiversità del nostro pensiero e della nostra specie. Intraprenderà l’unica strada tracciata, studierà l’inglese e a sua volta sarà capace di selezionare e proporre solamente autori da quella lingua. Troverà il lavoro in una redazione, tra altri simili o uguali a lui, dove le cose si capiscono ‘a occhi chiusi’, dove viene richiesta ‘l’immediatezza’, dove non si è invitati a ragionare fuori dal coro. Posso parlare di libri croati o serbi, ma con quali strumenti riuscirei a scegliere un libro finlandese? Potrei mai dedicarmi con la stessa passione alle tematiche che mi sfuggono e che non comprendo fino in fondo? Perché allora dovrei aspettarmi che lo facciano loro? Per una redazione è uno strazio immenso lavorare su una lingua per loro nuova, comporta molta fatica aggiuntiva, la revisione diventa un cruccio per tutti, e se i traduttori da lingue altre non mancano, i revisori sono una specie alquanto rara. Qualcuno in grado non solo di leggere il testo originale, ma di conoscere e amare quella cultura quanto te. Dove vengono a mancare loro, nessun redattore vorrà mettersi il cappio attorno al collo e abbandonarsi nel vuoto. Darà la preferenza ad altri titoli, quelli che lui stesso potrà leggere in originale. Il cerchio si chiude. Per fortuna esistono poi anche le realtà editoriali diverse, nate da chi in famiglia ha avuto presto i contatti non solo con l’inglese. A chi è stata inculcata la curiosità, chi ha fatto un viaggio, si è creato un amico, si è innamorato, da una qualsiasi altra parte del globo. La letteratura, quella migliore, si sposta quasi sempre grazie all’emozione che suscita al suo passaggio, e in questo non teme rivali. Avrà una strada più difficile da percorrere, ma una volta arrivata al lettore non rimarrà un titolo acquistato, letto e dimenticato. Le statistiche le potranno cambiare i nostri figli, forse, se forniamo loro un nostro contributo attivo, insegnando la differenza tra quantità e qualità. Perché sono loro a decidere cosa verrà pubblicato domani. Facciamo che non possano più fare a meno di Anna Maria Ortese, e la utilizzino da parametro per misurare altri testi.

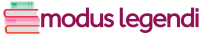

E così ma sel aletteratura serba in Italia vende poco, non resta molto da fare..un Editore coraggioso dovrebbe provare ad investirvi, senza farsi domande sul ritorno economico, oppure chiedere finanziamenti al MAECi o alla UE per un’opera di diffusione delle culture meno conosciute.. peccato perchèrappresnterebbe senza dubbio un arricchimento del nostro patrimonio culturale ed editoriale seil prodotto è molto buono dovrebbe comunque riuscire a conquistare una piccola quota del mercato editoriale..