“In Cina, caro mio, quasi ogni anno spunta fuori qualche nuova malattia interessante” è la battuta, dal tono vagamente premonitore, pronunciata da un cinico personaggio del testo teatrale Bílá nemoc (La malattia bianca), portato sulle scene a Praga nel 1937 da Karel Čapek (1890-1938). Come in tutte le opere dello scrittore ceco che, tra le altre cose, ha creato il personaggio letterario del robot, il fantastico irrompe nella quotidianità con tutta la sua carica di devastazione, come purtroppo avviene in occasione di ogni pandemia imprevista e sconvolgente. Dopo un sofferto dialogo con pesanti toni da tragedia medievale tra tre appestati, il vanitoso consigliere di corte Sigelius, nel corso di una autoreferenziale intervista propagandistica, spiega a un giornalista la natura della pandemia in corso: la malattia infettiva morbus tschengi (dal nome del medico cinese che l’ha descritta per primo), trasmessa “da un agens ancora ignoto”, contagia le persone con più di 45 anni, si manifesta con l’insorgere di macchie bianche sul corpo e ha già portato alla morte “almeno cinque milioni di persone”. Legata alla cupa atmosfera della fine degli anni Trenta, La malattia bianca rappresenta molto più che la dissoluzione di una società, affrontando il complesso problema del legame tra pandemia e svolta autoritaria. Čapek cerca affannosamente un artificio letterario per combattere la vertiginosa ascesa della dittatura militare in un bellicoso paese limitrofo, ricorrendo a un sofisticato rovesciamento del tema della degenerazione della razza, visto che a venire colpiti dal nuovo morbo sono proprio gli uomini dalla pelle bianca.
Il caso dello scrittore ceco non è certo nuovo e, com’è noto, le epidemie hanno offerto ripetutamente, nella storia recente e più remota, lo spunto per raccontare il crollo delle società e la disperazione individuale di fronte all’improvvisa diffusione di un nemico subdolo e invisibile. Spesso portata dall’esterno da inconsapevoli untori, poi liquidati come capri espiatori, la pandemia si è dimostrata uno strumento letterario potente per disegnare mondi distopici attigui al nostro, senza dover inventare complesse società sviluppatesi dallo sfruttamento di mirabolanti scoperte scientifiche o in conseguenza di incredibili viaggi intergalattici. Spesso metafore di derive ideologiche e sociali, le epidemie sono state sfruttate da scrittori molto diversi tra loro, da Daniel Defoe ad Albert Camus, passando per Edgar Allan Poe, Alessandro Manzoni, Jack London e molti altri. Ma, nelle società occidentali, in tempi recenti le pandemie sono tristemente tornate di attualità anche come fenomeni reali, rendendo nuovamente attuali testi e pellicole di molti anni fa.
Non c’è troppo da meravigliarsi che uno scrittore come Karel Čapek, da sempre legato al tema del difficile rapporto tra scienza e potere, abbia sentito, nel 1937, l’esigenza di scrivere un’opera teatrale in cui l’epidemia si fa metafora delle preoccupanti pulsioni totalitarie della vicina Germania. Sintomatiche delle preoccupazioni di molti intellettuali cechi, dopo l’ascesa di Franco in Spagna e la generale militarizzazione europea, sono anche le illustrazioni, opera del fratello dell’autore, il pittore Josef Čapek, tratte dal ciclo Gli stivali del dittatore, anch’esso del 1937. Nella Malattia bianca il tema della contrapposizione tra dittatura e democrazia si fonde in modo originale con quello della diffusione incontrollata della pandemia e della lotta per il dominio del pianeta per sollevare un profondo e sostanziale interrogativo: è lecito sottoporre i potenti del mondo a un “ricatto pacifista”, negando loro la cura di una malattia spaventosa, a meno che non rinuncino alle guerre?
Va ricordato che Karel Čapek aveva scritto un primo “ciclo” di opere a carattere distopico tra il 1920 e il 1924, in cui scoperte di carattere scientifico-alchemico alteravano l’ordine naturale delle cose, provocando la rovina del mondo. Nella fortunatissima opera teatrale R.U.R. Rossum’s Universal Robots (1920), di recente pubblicata in una nuova traduzione da Marsilio, aveva presagito l’introduzione nel mercato dei robot (in realtà sotto forma di androidi) che avrebbero dovuto affrancare l’uomo dal lavoro, creando un neologismo, in verità coniato dal fratello Josef a partire dalla parola ceca robota (lavoro servile, fatica) destinato a un incredibile successo.Poco dopo i palcoscenici mondiali hanno accolto con favore anche Věc Makropolus(L’affare Makropulos, 1922), messo in scena con grande successo anche in Italia da Luca Ronconi, in cui la scoperta dell’elisir della lunga vita rappresenta in realtà un pretesto per indagare i problemi connessi al desiderio di liberare l’uomo dalla morte. Nello sperimentale romanzo-feulleiton Továrna na absolutno(La fabbrica dell’assoluto, 1922), di cui Voland ha appena proposto una nuova traduzione, protagonisti sono invece degli stupefacenti “carburatori” nucleari che producono come materiale di scarto nientemeno che l’assoluto, la divinità, con il conseguente stravolgimento di ogni valore umano. Questa serie è stata chiusa da Krakatit (Krakatite, 1924), che finalmente Miraggi ha presentato per la prima volta anche ai nostri lettori sanando uno dei maggiori debiti dell’editoria italiana. Quest’ultimo romanzo vede il febbrile protagonista Prokop, scopritore di un devastante esplosivo basato sulla fissione nucleare, alle prese con la concreta opportunità di poter dominare il mondo. Se in tutte queste opere l’unica possibile soluzione al conflitto era la distruzione della scoperta che aveva provocato lo stravolgimento dell’ordine e il conseguente ritorno alla vita “naturale”, molto più cupo sarà il finale del secondo ciclo di opere utopiste della seconda metà degli anni Trenta. Del romanzo 1936 Válka s mloky (La guerra delle salamandre), uno dei testi in assoluto più noti di Čapek, esistono varie edizioni della stessa traduzione italiana, particolarmente preziosa è quella del 1961, arricchita dalle curiose illustrazioni di Tono Zancaro. Il romanzo riprende in una nuova forma sperimentale la formula dei robot, dando vita però all’evoluzione di un nuovo alter ego dell’uomo dalle caratteristiche ridotte e alterate, ideale per essere sfruttato a fini lavorativi e bellici. Il fossile di una grande salamandra estinta, all’inizio erroneamente attribuito da Johann Jacob Scheuchzer, nel 1725, a “un uomo che fu testimone del Diluvio universale” offre a Čapek la straordinaria opportunità di analizzare il totale fallimento dell’uomo nel rapporto con questo essere dalla “natura golemica e diabolica” (G. Giudici), che lo priverà progressivamente di ogni spazio vitale.
La malattia bianca, pubblicata dalla rivista Sipario nel lontano 1966 in un numero speciale dedicato al teatro cecoslovacco e mai più riproposta in italiano, porta invece sul palcoscenico un insolito scontro tra le pulsioni totalitarie della società e il curioso tentativo di imporre l’utopia della pace. Il medico Galén, ennesimo nome “parlante” dell’opera di Čapek, è infatti l’unico in grado di curare la pandemia ma, in cambio del siero, pretende dai potenti del mondo l’impegno a rinunciare alla guerra (“E io non la darò finché… finché non mi prometteranno che non si ucciderà più”). L’irremovibilità del medico, in evidente contrasto con il suo giuramento, incontra comunque il netto rifiuto del dittatore: “Non possiamo mica permettere che un qualsiasi utopista c’imponga le sue condizioni!”.
In un’atmosfera di febbrile militarizzazione e fabbriche a pieno servizio dell’industria bellica, di produzione di gas tossici e proposte di rinchiudere i malati in campi di concentramento, un inquietante Maresciallo vuole realizzare la sua “missione superiore” nell’interesse del suo popolo, e sta per proclamare la guerra contro “quel piccolo, miserabile staterello che aveva creduto di potere impunemente provocare e offendere il nostro grande popolo”. Il contesto non può naturalmente non richiamare la contrapposizione tra la piccola Cecoslovacchia democratica e la Germania nazista, che da lì a poco avrebbe portato alla fallimentare Conferenza di Monaco, che Čapek ha commentato infatti con queste amare parole: “non ci hanno venduti, ci hanno dati in regalo”. Non stupisce dunque che La malattia bianca, in modo alquanto inconsueto rispetto alla produzione dell’autore ceco, si chiuda senza alcuna speranza: quando il Maresciallo malato sembra deciso a proclamare la pace, Galén resta schiacciato nella ressa mentre sta andando a portargli la medicina. Il passo indietro del dittatore è quindi impedito da una folla ottusa che grida “Un traditore di meno. Gloria al Maresciallo!”.
Se Krakatite è un romanzo-mondo, che attira il lettore in un vortice di temi e stili diversi, anche La malattia bianca, diviso in tre atti intitolati “Il Consigliere di Corte”, “Il barone Krüg” e “Il maresciallo”, è un’opera che osserva le vicende da punti di vista divergenti e con cambiamenti di scena repentini. I tre atti possono essere infatti letti come i frustranti incontri/scontri di questo “bambinone”, com’era scherzosamente chiamato Galén da giovane, con la scienza, la grande industria e lo stato militare, in un momento di evidente deformazione del funzionamento delle società moderne. E qui il Maresciallo, il grande imprenditore Krüg (dal tedesco Krieg, la guerra), lo scienziato Sigelius (dal tedesco Siege, la vittoria) e la folla ideologizzata testimoniano il fallimento di un’intera società, chiaramente modellata su quella tedesca, anche se in Čapek non mancano mai i riferimenti al modello originale delle dittature degli anni Trenta, il fascismo italiano. Con grande gusto l’autore ceco si sofferma in particolare sulla malleabilità della scienza di fronte alle pulsioni totalitarie, offrendo una mordace satira del servilismo e sciovinismo di quelle classi intellettuali che, in un articolo, ha definito “prostitute dei regimi contingenti e delle loro ideologie”, vendutesi per “un piatto di lenticchie”. Ciò che sta a cuore all’autore è infatti il confuso legame tra populismo, potere e malattia, che tristemente vediamo all’opera anche nel tempo presente.
A questo piano della “grande storia” si alterna la storia privata di una famiglia normale, grazie alla quale l’autore, attraverso il carrierismo del padre, può rappresentare la pandemia anche come bieca occasione di guadagno economico e sociale. Non a caso alla fine proprio il figlio sarà uno dei capi della folla che provoca la morte di Galén, questa sorta di Don Chisciotte dell’epoca totalitaria. Figura dai tratti di un messia, obiettore di coscienza a qualsiasi costo, quest’ultimo è un cittadino greco naturalizzato, ex assistente universitario, ora medico della mutua per via della sua origine sospetta, non è un grande arringatore di folle, anzi spesso si limita a ripetere frasi semplici («ma davvero non è possibile»), e si comporta come uno straniero che osserva, suo malgrado, una società malata. La sua scoperta del siero permette a Čapek di sviluppare il tema del singolo che tiene in scacco l’intera umanità: nella prefazione ha ricordato che era stato un amico dottore a suggerirgli l’idea di un medico che scopre nuovi raggi potentissimi in grado di distruggere i tumori, cosa che dà presto allo scienziato un potere assoluto. Quello della responsabilità della scienza è del resto un tema che Čapek ha affrontato ripetutamente, in quest’opera rovesciando l’assunto di Krakatite: se lì era stato tratteggiato l’angosciante dilemma interiore di chi potrebbe diventare dittatore assoluto del mondo, qui è invece un medico che cerca di utilizzare il suo potere per il bene dell’umanità intera.
Se nella versione manoscritta dell’opera il medico si chiamava Herzfeld ed era ebreo, a testimonianza della critica espressa nella prefazione (“non più l’uomo, ma la classe sociale, lo stato, la nazione o la razza è ora portatrice di tutti i diritti”), nella versione definitiva il rimando è stato spostato dall’autore verso la cultura greca. Com’era già avvenuto in R.U.R. e Krakatite, la perdita dell’eredità classica segna infatti, nella nostra storia e nella nostra cultura, una cesura di tali proporzioni da spalancare la strada alla barbarie. L’ingenuo tentativo di Galén di sfruttare l’influenza sociale delle élite per ottenere la pace a ogni costo, contrapponendosi al vero dittatore ed ergendosi a medico-dittatore e fanatico della pace, termina però con un completo fallimento. Come purtroppo vediamo anche ai giorni nostri, conoscere i sintomi di una malattia, come a volte la letteratura è in grado di fare con grande anticipo rispetto alla scienza, non significa certo aver trovato una cura. Da questo punto di vista Galén è stato quindi giustamente considerato la «prima vittima della Seconda guerra mondiale».
Come spesso avviene nel caso delle opere letterarie dense e polisemiche, anche La malattia bianca assume oggi una serie di nuovi significati e si colloca in modo originale nella linea di opere letterarie centrate sulle pandemie che abbiamo tratteggiato. L’intera opera di Karel Čapek è infatti a lungo rimasta nell’ombra di una precisa linea evolutiva della distopia che, per semplificare, viene di solito descritta lungo la direttrice Wells-Zamjatin-Huxley-Orwell. Lo sperimentalismo con i generi letterari, il rifiuto del finale distopico e la mancata descrizione della società del futuro, collocano di per sé l’opera di Čapek in una posizione diversa. Anche se naturalmente non sono pochi i punti di contatto con molte importanti distopie della cultura occidentale, merita qui di essere citato almeno il film Vita futura (1936), con sceneggiatura di H.G. Wells, in cui un mondo distopico sconvolto dalla seconda guerra mondiale è attraversato in un lontano futuro da un’epidemia devastante («la piaga errante»).
Va inoltre ricordato che La malattia bianca rappresenta per Karel Čapek un ritorno al teatro dopo una pausa di vari anni, legato evidentemente alla necessità di far tuonare nuovamente la sua voce sul palcoscenico, nella sua concezione dello spazio teatrale come un pulpito da cui ammonire l’umanità. Le prime notizie su una nuova opera teatrale risalgono al dicembre del 1936, e il testo è stato pubblicato e messo in scena per la prima volta, a Praga e a Brno, nel gennaio del 1937. La rappresentazione ha suscitato, anche per l’attualità internazionale del tema, un’eco notevole, seguita poi dal conferimento del premio di stato per la letteratura. Uno dei grandi promotori della letteratura ceca all’estero nel periodo tra le due guerre, Max Brod, ne ha subito predetto il sicuro successo internazionale e Thomas Mann ha poi parlato di “successo trionfale” e di una fusione di elementi fantastici e simboli realizzata “con la maggiore vitalità e plasticità possibili”. Meno entusiasta è stato Karel Čapek rispetto alla messa in scena londinese del 1938 (con il titolo Power and Glory), in cui il regista ha deciso di far recitare i ruoli del dottor Galén e del Maresciallo allo stesso attore. Nella rassegnata riflessione affidata a una lettera inviata al Manchster Guardian, Čapek, pure avvezzo al continuo fraintendimento delle sue intenzioni, si è rammaricato della stravaganza di alcuni registi, paragonando l’intervento sulla propria opera a una rappresentazione in cui Otello e Desdemona venissero impersonati dallo stesso attore.
Senz’altro con maggiore interesse deve avere invece accolto la riuscita trasposizione cinematografica, realizzata in tempi brevissimi con gli stessi attori della messa in scena teatrale, anche se con un’importante modifica del finale: il Maresciallo infatti firma la pace e Galén, prima di morire, lascia a un collega la formula della medicina (il film si può vedere sul canale dei classici cechi: https://www.youtube.com/watch?v=HJMUIBEzYnI). La prima proiezione ha avuto luogo il 21 dicembre del 1937 ed è stata seguita, due giorni dopo, dalla vibrante protesta dell’ambasciata tedesca. Non c’è quindi da meravigliarsi se, dopo la conferenza di Monaco, nel novembre del 1938, il film sia stato immediatamente bandito dalle sale cinematografiche, anche se per fortuna, grazie a una copia portata all’estero, siano state poi prodotte le versioni francese e inglese.
Il tentativo di Karel Čapek di richiamare l’attenzione sui cambiamenti antropologici in atto nelle società occidentali e impedire la caduta della Cecoslovacchia era ovviamente destinato al fallimento, come hanno da lì a poco sancito le lugubri parole di Chamberlain nel suo discorso Peace for our Time, in cui, lasciando mano libera a Hitler, rifiutava la guerra “per una lite in un paese lontano, di cui non si sapeva niente”. La morte di Čapek, che ha assunto nel contesto ceco una chiara valenza simbolica, è apparsa qualche settimana dopo, davvero come la fine di un’epoca, anche se forse ha evitato all’autore una fine ancora peggiore. Qualche mese dopo infatti il fratello Josef, uno dei pittori cechi più significativi della prima metà del XX secolo, sarebbe stato arrestato e trascinato nei campi di Dachau, Buchenwald e Sachsenhausen, per morire poi a Bergen-Belsen poche settimane prima della fine della guerra.
Come dimostra la sensazione di assoluto pessimismo con cui termina La malattia bianca, in Karel Čapek si era indebolita la fiducia nella gente comune e nella reale possibilità di fermare l’avanzare del totalitarismo. Anche se la situazione storica è oggi completamente diversa, si tratta di temi tornati di grande attualità ed è sempre più necessario tornare a interrogarsi su quali siano i rapporti tra potere, populismo, fanatismo e pandemia. Il grande potere della letteratura è in fondo proprio quello di anticipare molti problemi prima della loro esplosione e Čapek, negli anni Venti e Trenta, ha sollevato delle questioni nodali che hanno poi angosciato l’immaginario delle nostre culture per tutto il XX secolo. Nel 1937, agli occhi di un autore ceco sulla soglia di una catastrofe che sta per inghiottire tutto il mondo, la risposta è tristemente univoca: nemmeno una pandemia è in grado di bloccare la deriva militarista della società europea e, una volta linciato Galén, il corteo prosegue urlando i suoi triti slogan, “Viva la guerra! Viva il Maresciallo!”.
Karel Čapek (Malé Svatoňovice 1890 – Praga 1938), giornalista, drammaturgo e narratore, è stato uno dei maggiori scrittori cechi del Novecento ed è stato ripetutamente tradotto in italiano fin dagli anni Venti. Grande sperimentatore di nuove forme e generi letterari, ha affrontato nella sua opera temi di grande attualità: l’intelligenza artificiale, l’energia atomica, la diffusione di epidemie etc. Deve la sua consacrazione internazionale all’opera teatrale R.U.R. Rossum’s Universal Robots (1920), che ha introdotto nella cultura mondiale il termine “robot”. Molto noti sono anche l’opera teatrale L’affare Makropulos (1922), i Racconti da una e dall’altra tasca (1929) e i romanzi La fabbrica dell’assoluto (1922), Krakatite (1924) e La guerra delle salamandre (1936).

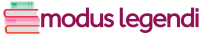



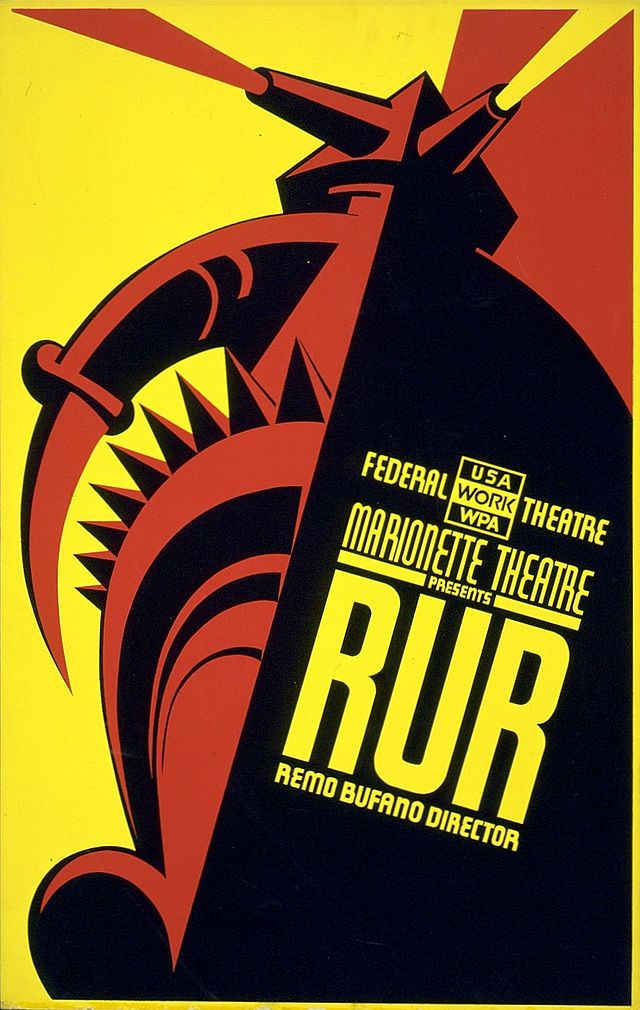
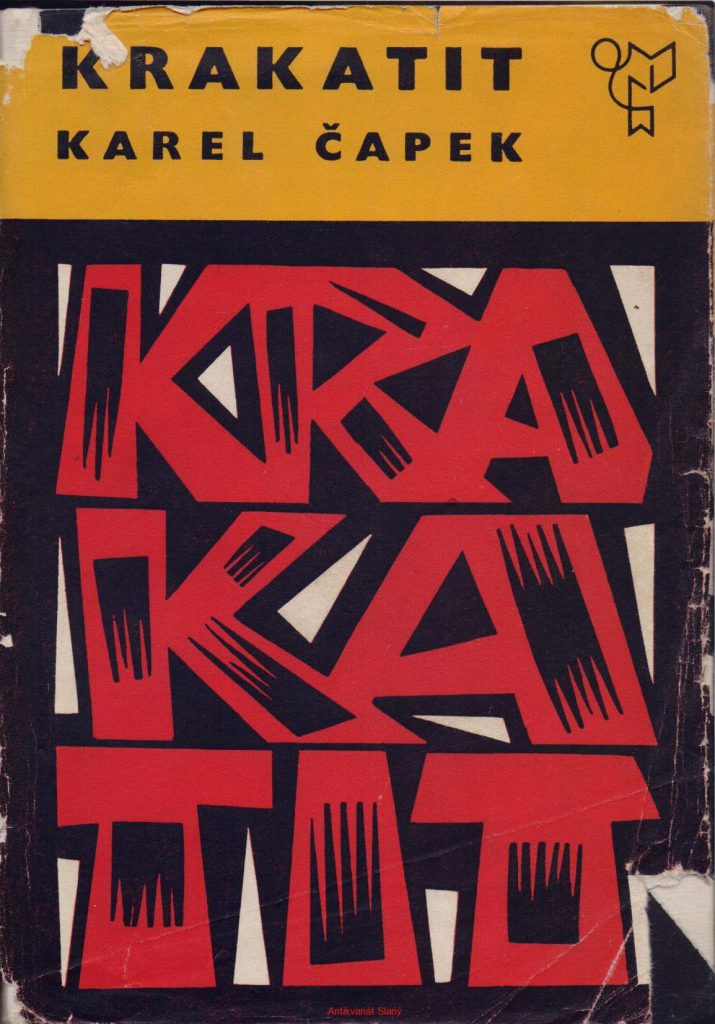
Grazie per la ricchezza di informazione sull’opera di uno scrittore di sconvolgente attualuta’
Grazie per avermi fatto scoprire La Malattia Bianca di Capek. Purtroppo però il testo italiano he vorrei tanto approfondire è introvabile. Potete aiutarmi indicandomi dove reperirlo in rete o condividendo la traduzione del ’66 cui si accenna nell’articolo !? Vi ringrazio anticipatamente.
Maurizio