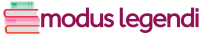Chi si è ispirato a chi, nelle Immagini del famoso ma sconosciuto Filostrato?
L’opera stessa è un enigma. C’è una villa, nei pressi di Napoli, della quale non sappiamo nulla: né la posizione, né la effettiva esistenza. Ci sono sessantaquattro pitture che ne ornano la stoa, il portico: ma i pittori sono ignoti, e le pitture stesse sono andate perdute (e a parte questo: sono realmente state dipinte? Alcuni critici dubitano). C’è uno scrittore – Filostrato – del quale pure sappiamo poco o niente (è Filostrato di Lemno detto Il Vecchio? Oppure il Filostrato figlio di Nerviano?), che le descrive a un gruppetto di giovani, e a uno di loro in particolare: il “ragazzo mio”, il tu della narrazione. Filostrato precorre con le sue Immagini la fortuna dell’ékphrasis, “la rappresentazione verbale di una rappresentazione grafica” (Heffernan), che dilagherà nei secoli successivi. Ma questo primo esperimento, quasi l’incunabolo di un genere, si trasforma in una sorta di matrioska delle arti: la rappresentazione verbale di una rappresentazione grafica di una rappresentazione verbale. Il narratore ci racconta delle pitture che a loro volta raccontano delle storie che però sono già state raccontate – Narciso innamorato che cade nella fonte cercandosi; Fetonte che precipita dal carro del Sole – da poeti come ad es. Ovidio. Ma non è tutto, perché il gioco di specchi specchiantisi l’uno nell’altro continua nel Rinascimento, la grande stagione delle arti sorelle, quando le Immagini circolano grazie alla stampa e pittori come Mantegna, Tiziano e Giulio Romano ne tentano una traduzione visiva: dalla parola alla pittura alla parola alla pittura a… lo specchio continua a riflettere Narciso, che s’inganna (o è la pittura a ingannarlo?):
“Non vedi che l’acqua riproduce te stesso nell’atto di contemplarti, non ti accorgi dell’artificio di questa fonte, eppure basterebbe che ti sporgessi appena o che cambiassi espressione, o che agitassi la mano o che ti spostassi. Ma, come se avessi incontrato un compagno, resti immobile in attesa degli eventi. Credi forse che la fonte prenderà a conversare con te?”
È un tu così ambiguo, questo di Filostrato. Sta forse parlando a Narciso? E a quale Narciso, quello della storia o quello dipinto? E se stesse invece parlando al giovane, al destinatario finzionale del racconto, e per estensione a noi, destinatari immaginati della narrazione? È un avvertimento, il suo? Non aspettiamoci troppo dalla pittura, perché la pittura è silenziosa, non conversa con noi, non ci risponde. Sta, anche lui, scagliando un martello contro quel muro muto?
Se le immagini non parlano, poeti e scrittori hanno continuato a parlare al posto loro. Per Baudelaire ogni vero poeta finiva per essere, e del tutto naturalmente, un grande critico (“Sarebbe prodigioso che un critico divenga poeta; è impossibile che un poeta non sia anche critico”). Proust infarcisce la Recherche di pittori – da Beato Angelico a Poussin, da Tiepolo a Tintoretto, da Velàzquez a Vermeer – ma la vera registrazione delle sue emozioni difronte all’opera d’arte si dà nei brevi e godibilissimi saggi che lo scrittore dedica ad alcuni maestri: Rembrandt, Chardin, Watteau, Moreau, Monet. Anche qui abbiamo un giovane che, dopo essersi riempito gli occhi degli splendori dei musei, delle cattedrali, del mare e delle montagne, si trova a guardare “con disagio e fastidio, con una sensazione prossima al disgusto, con un sentimento vicino allo spleen, un ultimo coltello abbandonato sulla tovaglia già mezzo sollevata che pende sino a terra, accanto a un resto di costoletta sanguinolenta e insipida”. È la banalità delle cose quotidiane, comuni, le cose della vita orbata di ogni meraviglia. E allora, dice Proust, per recuperarla, questa meraviglia, e in quelle stesse cose comuni, il giovane “non lo dissuaderei dal recarsi al Louvre, ma piuttosto ve lo accompagnerei; e, conducendolo nella galleria Lacaze e in quella dei pittori francesi del Settecento, o in un’altra sala francese, lo costringerei a fermarsi davanti a Chardin. E, quando lo vedessi rapito in estasi davanti a quella pittura opulenta di ciò che lui chiamava la mediocrità, a quella pittura saporosa di una vita che gli appariva insipida, di quella grande arte di una natura che gli sembrava meschina, gli terrei questo discorsetto”.
Segue un elenco di opere di Jean Siméon Chardin che illustrano scene di vita borghese oppure francamente contadina e modesta. Ambienti non da artisti, non da letterati, ma da sartine, da cuochi, da servitù, come ne La raie: “un interno di cucina in cui un gatto vivo cammina sopra delle ostriche, mentre una razza morta pende da una parete”. A Chardin tutto questo apparve bello da vedere, e dunque bellamente lo dipinse, rendendolo altrettanto bello per chi lo guarda. È un’educazione allo straniamento, all’osservazione del consueto con lo sguardo acutizzato, rimpolpato, dislocato rispetto all’interpretazione più semplice e ovvia. Uno sguardo che è, secondo Proust, alla portata più degli artisti del pennello che degli artisti della parola: “D’ora innanzi, spero che, per istrada o in casa, vi piegherete con rispettoso interesse su codesti caratteri ormai frusti, che, se saprete decifrarli, vi diranno molte più cose, che non i più venerandi manoscritti”.
Alcuni artisti sono stati molto amati, citati e frequentati da chi scrive. Guido Reni, per esempio. “Di un quadro di Guido”, scrisse Stendhal, “si può dire ʻÈ un capolavoro!ʼ con il maggior sangue freddo del mondo”. Lo stesso deve aver pensato Giambattista Marino, in quel suo tentativo, nel 1620, di produrre una vera e propria galleria (anzi: Galeria) in versi:
Che fai, Guido? che fai?
La man che forme angeliche dipigne,
tratta or opre sanguigne?
Non vedi tu, che mentre il sanguinoso
stuol dei fanciulli ravvivando vai,
nova morte gli dai?
O ne la crudeltate anco pietoso,
fabbro gentil, ben fai,
ch’anco tragico caso, è caro oggetto,
da che spesso l’orror va col diletto.
Questa la sua rilettura de La strage degli Innocenti (1611), dipinto custodito alla Pinacoteca Nazionale di Bologna.
Se per Marino l’orror di Reni va col diletto, per Mishima si appaia all’eccitamento sessuale. Mai come in Confessioni di una maschera un’opera d’arte, presentata con una descrizione molto vicina all’ékphrasis (“Un giovane di singolare avvenenza stava legato nudo al tronco dell’albero, con le braccia tirate in alto, e le cinghie che gli stringevano i polsi incrociati erano fermate all’albero stesso”) diventa personaggio agente all’interno di una relazione. La descrizione presto dilegua, muta nel resoconto di una pulsione sessuale che è mediata dall’opera o pungolata dall’opera o forse è l’opera stessa. Se l’atto sessuale è una fusione, qui certo abbiamo la fusione tra finzione pittorica e finzione letteraria: davanti al San Sebastiano di Guido Reni il narratore si masturba per la prima volta, scoprendo il piacere, quel diletto che – in un rovesciamento del Marino “alla giapponese” – va con l’orror: “Non è la sofferenza che aleggia sul petto dilatato, sull’addome teso, sulle labbra appena contorte, ma un tremolio di piacere malinconico come una musica. Non fosse per le frecce con le punte confitte nell’ascella sinistra e nel fianco destro, egli sembrerebbe piuttosto un atleta romano che allevia la stanchezza in un giardino, appoggiato contro un albero scuro. Le frecce si sono addentrate nel vivo della giovane carne polposa e fragrante, e stanno per consumare il corpo dall’interno con fiamme di strazio e d’estasi suprema”.
L’orgasmo della santità mischiato all’orgasmo sessuale, come forse solo un autore di cultura non cristiana poteva azzardare.
E dunque qui, tra le due arti, chi rincorre chi? Chi supera chi? Chi imita chi?
I Disegni per la Divina Commedia di Botticelli (1480-1495) sono semplice illustrazione? O non sono forse, come ha suggerito Giulio Carlo Argan, un vero e proprio commento all’opera?
Dall’Ut pictura poesis di Orazio, al quale è stato dato un valore normativo che esulava dalle intenzioni del poeta; al detto di Simonide di Ceo riferito da Plutarco: “La pittura è poesia muta e la poesia è pittura parlante”; al già citato passo di Leonardo… Sembra che la relazione fra letteratura e arti visive abbia la forma di quegli antichi uomini descritti da Aristofane nel Convito di Platone. Uomini-palla o uomini-sfera, con ogni cosa doppia: quattro mani e quattro gambe, due facce rivoltate l’una contro l’altra, incassate sopra un tondo collo, e quattro orecchie e due sessi, uguali fra loro oppure diversi. E questi uomini, dice Aristofane, a causa del loro eccesso nel corpo eccedevano anche in talento, in forza e in ambizione. Tentarono una scalata al cielo e Giove, per difendersi senza perderli, si risolse a tagliarli in due, come si fa con un uovo. Li indebolì, trasformandoli in esseri intrinsecamente carenti, esseri gravati da una nostalgia curabile solo con la ri-scoperta e la ri-unione con l’altro, la parte mancante. Le due parti si cercano, si abbracciano, si avviticchiano e si congiungono. E così da sempre fanno le due arti. Separate per eccesso di orgoglio in un tempo lontano in cui segno naturale e segno arbitrario si compenetravano tanto da essere indistinguibili, arti visive e arti della parola hanno continuato a desiderarsi, e talvolta anche ad attaccarsi e accusarsi, come sempre attacchiamo e accusiamo la persona dalla quale non riusciamo a scioglierci e di cui per sempre, lo sappiamo, sentiremo la mancanza.
“E la cagione è che noi eravamo così anticamente, interi: e il desiderio e lo struggimento di tornare interi, chiamasi Amore”.
Artisti e letterati cercano forse questo: di riscoprire l’antica unità, la primeva compiutezza.
Dai calligrammi di Apollinaire, alle sperimentazioni delle avanguardie, alle integrazioni spinte della poesia visiva fino alla “poesia totale” di Adriano Spatola, dove la parola si fa definitivamente oggetto, rifiutando i canoni tradizionali della lettura.
E non procedeva allo stesso modo Francis Ponge? In quel suo ridurre, logorare e al tempo stesso raffermare la parola trasformandola appunto in oggetto, “intesa più come funzione semantica a mezzo che come finalità significativa raggiunta” (Bigongiari).
“Una conchiglia è una piccola cosa, ma posso smisurarla rimettendola nel luogo in cui la trovo, depositata sulla distesa della sabbia. Prenderò allora una manciata di sabbia e osserverò il poco che mi resta in mano quando tra le mie dita quasi tutta la manciata di sabbia sarà scivolata via, osserverò alcuni granelli, poi ogni granello, e nessuno di quei granelli di sabbia mi sembrerà più una piccola cosa; e ben presto la conchiglia formale, questo guscio di ostrica, o questa tiara bastarda, o questo cannolicchio mi impressionerà come un enorme monumento, colossale e prezioso ad un tempo, qualcosa come il tempio di Angkor, Saint-Maclou o le Piramidi, con un significato ben più strano di questi troppi incontestabili prodotti umani”. (Francis Ponge, Appunti per una conchiglia da Il partito preso delle cose).
Quest’alternanza (o simultaneità?) tra microscopio e macroscopio è il tentativo dell’artista della parola di saturare l’immagine reale per spalancare la porta a tutto un insieme di suggestioni figurali, così da ottenere la tanto agognata ricomposizione tra segno arbitrario e segno mimetico. Il ritorno a quel corpo tondo e autosufficiente (mentre le singole arti, le parti singole, sono autoinsufficienti). Un corpo di sé orgoglioso. La parola torna a essere immagine, o meglio cosa, mot-chose, e l’immagine è a sua volta esistente ma solo perché immaginata attraverso la parola nella sua facoltà costruttrice.
Se in Ponge abbiamo la vittoria dell’immagine attraverso la parola e la vittoria della parola attraverso l’immagine, in Alain Robbe-Grillet abbiamo invece la sconfitta di entrambe: “Quella faccia gigantesca, coi biondi capelli ondulati, gli occhi contornati da lunghissime ciglia, le labbra rosse, i denti bianchi, si presenta di tre quarti, e guarda sorridendo i passanti che arrancano e la oltrepassano uno dopo l’altro, mentre accanto a lei, sulla sinistra, una bottiglia di bibita effervescente, inclinata di quarantacinque gradi, volge l’imboccatura verso la bocca dischiusa. La dicitura è scritta in caratteri corsivi, su due righe: la parola ʻancoraʼ posta al di sopra della bottiglia, e le due parole ʻpiù puraʼ al di sotto, nella parte bassa del manifesto, su una linea obliqua lievemente ascendente rispetto al bordo orizzontale di questo”. (Alain Robbe-Grillet, Un sottopassaggio, da Istantanee)
Nella descrizione che Robbe-Grillet fa di questo manifesto pubblicitario la scomposizione è tale che non riusciamo più a cogliere il segno naturale, se non nella sua innaturalità. Vediamo, ma non vediamo. Cogliamo le parti, ma ci è negato l’insieme. La parola, qui, distrugge. La parola è come l’occhio che, avvicinandosi a un oggetto, e poi avvicinandoglisi ancora, ingrandendolo più e più volte, finisce per annullarne la forma: indaga qualcosa d’altro, un qualcosa che se pure è fisico – la struttura invisibile della materia – non può essere colto dai sensi. Un’arancia, vista al microscopio, non è più un’arancia. Il pane non è più pane, l’ostrica non più ostrica, la farfalla non più farfalla. Il partito preso delle cose non esiste più: la strada porta fuori da esse e verso la mente – il concetto puro. Lo sguardo dell’école du regard è, come lo ha definito Piero Bigongiari, “tattile e cieco”. È la mano di Michelangelo che afferra il martello e lo sferra contro il ginocchio dell’opera finalmente parlante, per imporle un nuovo silenzio.