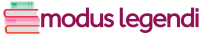Qui la prima parte dell’articolo.
Ma è nel secondo racconto che, in maniera ancora più radicale, la memoria si rifiuta di assolvere qualunque consolante funzione. Euvgenij Petrovič, la voce narrante, soffre di un male oscuro, lo stesso che ha colpito i diamanti di un paio di orecchini, venerati perché testimoni della sua fedeltà ad una emozionante felicità perduta. I gioielli sono quindi il correlativo oggettivo del male che gli ha divorato, senza speranza, l’anima.
Ormai da tempo vivevo nella più totale indifferenza, e la gente non ama questo atteggiamento, non ti nota più, anche gli specchi rifiutano di riflettere la tua immagine e l’eco non ti risponde. … Non riesco ad estirpare questo male nero, non riesco a resuscitare. … Sono anch’io come uno specchio che non riflette più nulla. [1]
Euvgenij, molto tempo prima, ha perso la donna che amava e ha impegnato i suoi orecchini per pagare l’ospedale e il suo funerale, ma, davvero in un’altra vita, aveva già perduto tutto il resto: famiglia, amici, posizione, la patria e i ricordi, quelli veri, normali. Ora attraversa i suoi giorni come un vampiro che ha dissanguato sé stesso, eppure, senza le tracce che, suo malgrado, le persone che incontra gli lasciano addosso, non potrebbe fare nulla.
Solo convivendo con Alja, una ballerina squattrinata, abituandosi alle sue collane e ai fiori sparsi per casa, riesce a mettere da parte i soldi per andare negli Stati Uniti.
E, una volta lì, l’aria di plastica dell’America (…Per strada i passanti odorano di canfora e di naftalina. Hanno dovuto tirare fuori le giacche pesanti e i cappotti, che erano già stati riposti per bene, in vista dell’autunno successivo. Si sa che l’odore di canfora e naftalina uccide l’amore. [2] ) non gli impedisce di vedere l’ipocondriaco Kaljagin come un essere umano bisognoso di affetto e contatti fisici e di riconoscere l’amore inutile e profondo che sua figlia Ljudmila concepisce per lui.
Anche il lettore è ossessionato dal giro verso il nulla compiuto da Evgenij, un tour classico, del resto, dell’emigrazione del secondo dopoguerra: Parigi, New York, nuova meta in America, in questo caso, la tenebrosa Chicago dove, secondo il non senso interiore di Evgenij, lo attenderebbe un amico misterioso: un certo Druzin che, va da sé, non esiste, come il suo stesso cognome annuncia, la radice è la stessa della parola russa druzba, che significa: amicizia, ma forse potrebbe anche comparire, essere da qualche parte, come un angelo che si manifesta finalmente al suo protetto.
Vale la pena di soffermarsi su questa Chicago dell’anima. La città possiede un potere infernale e tenebroso, quartieri di cartapesta si disegnano contro un cielo incendiato da un tramonto elettrico, davanti al quale si scorge la sagoma dell’Isola delle Oche (ma ci sarà davvero?).
…quartieri avvolti in tenebre tempestose, che si stendono da nord a sud lungo il fiume… In queste strade strette, dalla sommità dei tetti fino al selciato pendono delle scale esterne antincendio, che con le loro linee spezzate si stagliano contro il cielo, bianco di giorno e rosso di notte… capita che vi dormano accucciate delle figure immobili, che penzolano nel vuoto simili a sacchi neri. [3]
Veramente va detto che la metropoli americana, le sue larghe strade che sembrano condurre l’europeo verso il nulla, è il simbolo della mancata funzione di vero recupero della memoria. Vi è del resto una ragione per la quale tutte le città, Parigi compresa, sembrano così minacciose, perché nascondono l’epifania di una assenza, invece che di una presenza: tutte sono infatti delle semplici controfigure di quella Pietroburgo, mai più ritrovata neppure nei ricordi, la cui magica e allucinata atmosfera continua a gettare ombre sulla vita di chi l’ha abbandonata [4].
Il cielo americano mantiene la stessa innaturalità di quello russo, ma le dolci notti bianche, che facevano di ogni albero un caro fantasma, di ogni piazza lo scenario di un sogno, si sono trasformati in un incubo infernale di fuoco e tenebra sul quale si stagliano cariatidi di condomini e di galere. Chicago è l’ossessione estrema della memoria, delle cose come erano e come sono diventate.
Del resto Evgenij, per continuare a vivere, non oppone alla terra bruciata che ha dentro di sé, la funzione fallimentare della memoria, ma l’uso ideale della coscienza, così come lo ha enunciato Yuri Zivago, nel romanzo di Pasternak:
La coscienza è luce proiettata al di fuori e che illumina la strada davanti a noi, perché non si inciampi. La coscienza sono i fari accesi davanti ad una locomotiva che corre. Rivolgete la loro luce all’interno e succederà una catastrofe[5].
Se non ci fosse questa coscienza che si rifiuta di illuminare fino in fondo ciò che non potrà più tornare, il protagonista non potrebbe avere scampo dal vizio del ricordo diventato sadico piacere che impedisce di vivere, è quindi solo attraverso la coscienza che egli ritrova la fedeltà al passato, che, nel suo caso coincide con la dedizione commovente ad una donna morta e al proprio Paese che non esiste più, gli capita infatti di riflettere sulla folla, le città e le bandiere, con esemplare indifferenza:
Ne ho viste molte in vita mia, grandi e piccole, ma le ho sempre capite e amate. Le abbiamo amate finché non hanno cominciato ad andare in rovina una dopo l’altra. E allora abbiamo iniziato ad averne un poco paura[6].
Se il tema della città domina questo racconto, è perché nessuna forza nel 1900 è più stata veramente in grado di ricomporre la madeleine. Dobbiamo accettare che giaccia in fondo alla tazza del tè, mentre uomini e angeli scivolano lontano dalla città del sogno e si spengono per sempre le luci giallognole dei lampioni a gas, così come il richiamo cantilenante del venditore di miele turco si perde nella desolazione dell’anima. Del resto, ogni rappresentazione ha fine.
Ogni spettacolo è un castello di sabbia, un’effimera cattedrale che, con il passare degli anni, perde i contorni, tremola, si assottiglia nell’acqua della memoria[7].
Comunque, nella letteratura russa, già Čechov aveva sottolineato come l’anima del mondo fosse una sola e cose e persone si trovassero in essa confuse, e se gli oggetti materiali diventano umani, anche gli uomini rischiano di diventare delle cose, materializzati e ridotti ad oggetti da consumare[8].
Alla fine di questa chiacchierata, resta la copertina di un libro di recente pubblicazione, si intitola Memoria della memoria, l’autrice è Marija Stepanova[9].
L’impatto è forte, sulla carta, in un glassato color dagherrotipo, esplode una complicata e ottocentesca porcellana, riempendo di pezzi scheggiati l’intera copertina. Molto più che una metafora, la porcellana che nessuno può più incollare, anticipa il metodo narrativo dell’autrice, che non ha alcuna intenzione di raccontare tutti gli eventi della sua famiglia, né in modo cronologico, né anacronico, quindi al lettore devono bastare le notizie che la narratrice è disponibile ad affidargli e chiudere il libro con la voglia di sapere quello che, per intero, non si può più dire in una lingua che possa essere compresa dai più, perché
Di sicuro la vita non può che iniziare con una sciagura spesso accaduta molto prima di noi, cui non serve affatto la nostra partecipazione o il nostro permesso… una disgrazia è condizione imprescindibile per la nostra comparsa…[10].
Qualche riga dopo, la voce narrante aggiunge:
Non dirò che sul balcone di casa, che anche ora si trova in vicolo Chochlovskij, settant’anni fa c’era un criceto in gabbia. Il criceto correva, la ruota girava, la ragazza stava a guardare.[11]
Il passaggio è tutto in quel non dirò, il primo dei molti con cui, in effetti, finisce con il dire tante cose, ma ne omette altrettante di quei centotrent’anni di famiglia che non è più possibile raccontare come prima, ovvero prima che la ferita originaria privata si fondesse con quella collettiva, e le persone e i personaggi diventassero, come suggerisce lo stesso Roth, una cosa sola.
…quanto più si prolungava l’emigrazione, tanto più i russi si avvicinavano all’immagine che ci si era fatta di loro. Come per farci un piacere si assimilarono al nostro cliché… Il principe russo, che fa lo chauffeur a Parigi, guida il suo taxi diritto nella letteratura[12].
Il romanzo di un certo ‘900 sembra dirci che della nostra vita resta ben poco al di là dello sforzo (qualche volta dello sfarzo) delle parole, niente più che il cimitero di Saint-Germain, descritto in un lungo libro-confessione dalla stessa Berberova:
Lì giacciono i manovali della Renault e i premi Nobel, i granatieri di “sua altezza” e i poveri del sagrato della chiesa di rue Daru…i sarti e le ballerine…gli agenti di Stalin … e coloro che accendevano ceri davanti all’icona dello “zar-martire”. Lì, come conviene ad un cimitero, tutto ha fine[13].
Va aggiunto che nessun secolo lo ha saputo con la disperata lucidità del 1900.
Così la consolazione della memoria ci lascia; in parte anche perché la scrittura, oggi, fa fatica a trovare il punto in cui il genio delle parole non abbia paura della debolezza e si teme che il lettore soffochi con la madeleine troppo sontuosa e zuppa di tè.
Ma, bisogna anche dire che è sempre più difficile amare la memoria, perché è necessario accettare di essa il lato oscuro, quello che trascina con sé rimorsi e rimpianti e pagine e ancora pagine da leggere con sufficiente passione per la scrittura e per il passato.
E ancora, lo scrittore fa fatica a imbastire attraverso il recupero dei ricordi una giustificazione plausibile della disgrazia e del male, come ben sapeva Hannah Arendt, quando parlava del fattore-sfortuna nella vita di Walter Benjamin, e lo descriveva come qualcosa di piuttosto oggettivo[14].
Ma il romanzo esisterà fino a quando ci saranno storie da raccontare, infanzie da superare, guerre da dimenticare e il critico-alchimista, di cui parla sempre la Arendt, proseguirà a mettere in pratica
…l’oscura arte di trasformare i futili elementi del reale, nello scintillante, duraturo oro della realtà…[15]
Questa rimane la vera forza della scrittura, anche quando cedo davanti ad una sorte incomprensibile:
In cantina voglio andare, / Il mio vino voglio bere; / Ma un gobbetto ahimè compare/ E si beve il suo bicchiere.
In cucina voglio andare / Scaldar voglio il mio brodino; /Ma un gobbetto ahimè compare/ E mi rompe il pentolino.
Walter Benjamin, Infanzia berlinese, 123
[1] Nina Berberova, Il male nero, trad.it. di Gabriele Mazzitelli, Parma, Guanda, 1990, p.87.
[2] Nina Berberova, Il male nero, op. cit, p. 41.
[3] Nina Bereberova, Il male nero, op. cit., p. 58, 59.
[4] Sulla magia malata di Pietroburgo, nessuna fonte è migliore di un saggio che è ormai un classico: Ettore Lo Gatto, Il mito di Pietroburgo, Feltrinelli, Milano, 1991. In questo lavoro, lo studioso ripercorre tutta la storia della tetra finestra sull’Europa, voluta da Pietro il Grande, eternamente contrapposta al mito slavofilo di Mosca, terza Roma. Definita Palmira del Nord, regina del Secolo della Ragione, Lo Gatto lascia l’immagine di città di eccezionale magnificenza, per addentrarsi in quella della capitale strappata, con grandi costi umani, ai flutti maligni e a i miasmi delle paludi, ma destinata a ritornare al mare in una ecatombe collettiva. Sempre sull’eredità dei luoghi e l’influenza di essa sulla letteratura, segnalo un altro classico in ambito saggistico, assolutamente imprescindibile: Angelo Maria Ripellino, Praga magica, Torino, Einaudi, 1991. Lo studioso, rievocando l’epopea della città dai tempi di Rodolfo II, resuscita un mondo di alchimisti che cercavano l’oro chimico; del Golem, animato per ripetere la creazione divina; di antri, bordelli, negozi, piazze illuminate dalle luci di Natale, case che nascondono segreti inconfessabili: “…città per cui vagano strampalati commandos di alchimisti, di astrologhi, di rabbini, di poeti, di templari acefali, di angeli e santi barocchi, di arcimboldeschi fantocci, di marionettisti, di conciabrocche, di spazzacamini.” Cfr. A. M. Ripellino, Praga magica, op. cit. p.9. Certi caratteri delineati in questo libro, sono importanti per definire un certo tipo di anima slava, come la troviamo in alcuni personaggi maschili e femminili della Berberova. “Le calze verde-lucherino, le bieche lanterne, ampolle di rosso liquido medicinale, nella notte viziosa del ghetto. In molti bordelli suonavano arpiste cieche.” Cfr. A.M. Ripellino, Praga magica, op. cit., p.153.
[5] Boris Pasternak, Il dott. Zivago, trad.it. di Pietro Zveteremich, Feltrinelli, Milano, 1985, p.57.
[6] Nina Bereberova, Il male nero, op. cit., p. 84.
[7] A. M. Ripellino, Introduzione a: Il trucco e le anime, Torino, Einaudi, 1965, p. 11.
[8] Seguo: Vittorio Strada: L’esordio teatrale di Cechov, compreso in: Tradizione e rivoluzione nella letteratura russa, Torino, Einaudi, 1980.
[9] Marija Stepanova, Memoria della memoria, trad.it. di Emanuela Bonacorsi, Milano, Bompiani, 2020.
[10] Marija Stepanova, Memoria della memoria, op. cit, p. 449.
[11] Marija Stepanova, Memoria della memoria, op. cit, p. 452.
[12] Joseph Roth, Viaggio in Russia, trad. it. di Andrea Casalegno, Adelphi, Milano,1991, p. 20.
[13] Nina Bereberova, Il corsivo è mio, trad. it. di Patrizia Deotto, Milano, Adelphi, 1989, p. 483.
[14] Hannah Arendt, Il pescatore di perle, trad. it. di Andrea Carosso, Milano, A. Mondadori, 1993, p. 11. Nel libro, la studiosa mette in relazione il fattore-sfortuna con le disgrazie effettivamente capitate a Benjamin. Egli stesso temeva la cattiva influenza dell’Omino-Guastatutto, un personaggio delle fiabe tedesche, incontrato nell’infanzia e mai dimenticato, e spesso era incline a non tener conto dei pericoli reali.
[15] Hannah Arendt, Il pescatore di perle, op. cit, p.10.