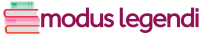A me è parsa un’eternità atemporale, un rigurgito perpetuo in cui ogni cosa subiva un torpore disomogeneo che rallentava la visione e ingigantiva l’affanno. (Angelo Di Liberto, Confessione di un amore ambiguo)
C’era una volta uno dei più grandi scrittori di tutti i tempi, un giorno un suo amico offrì in anteprima una parte di un suo lungo romanzo, si chiamava ancora semplicemente Swann, ad un editore-libraio piuttosto noto di Parigi e si sentì rispondere, più o meno, che il libro era impubblicabile. Il nostro editore disse che non riusciva a capire come lo scrittore avesse impiegato trenta pagine a raccontare al lettore come si rigirava nel letto, prima di prendere sonno[1].
André Gide aveva già giudicato il logorroico artista come: un oscuro dilettante mondano, e si rifiutò di prestare oltre attenzione alle pagine che gli erano arrivate, cassando in un sol colpo la madeleine con il buon tè di tiglio e con essa il fantasma venerando della zia Leonie.
Finisce così la prima avventura della memoria nel romanzo del 1900 e se oggi Proust è uno degli autori più amati e conosciuti, lo è per gli stessi motivi per i quali i suoi contemporanei faticarono non poco ad accostarsi al suo mondo perduto e ritrovato. Questi aspetti possono essere, in maniera certo sommaria, definiti per due principali caratteristiche: il tempo si deforma (all’interno della Recherche, il lettore si deve un po’arrangiare, i punti di riferimento precisi sono pochi e i termini analessi e prolessi non sono sufficienti a descrivere la dilatazione di certi argomenti e momenti della narrazione o il salto temporale che inghiotte, senza preavviso, interi decenni); il protagonista, ma lo stesso si può dire degli altri personaggi, si sfalda, come succede qualche volta nella vita, in una serie di io multipli, che mettono in crisi la nozione di soggetto, contestandone la continuità, a favore di personalità successive sempre messe in discussione.
Sembrerebbe quindi che la coscienza possa esistere solo in una dimensione perpetuamente mutante, che rende i personaggi sfumati ed irraggiungibili. Esempio di ciò è l’abilità, ben nota ai lettori di Proust, di cogliere i tic, le nevrosi, le bugie mondane che segnano le tappe della coscienza ondivaga, penso al barone Charlus, che dichiara di trovare detestabili i ragazzi di cui si innamora perdutamente o al parvenu Legrandin, tradito da un modo obliquo di guardare, che ne svela l’anima arrivista.
Proust non aveva letto Freud, ma siamo nel pieno del lapsus e del motto di spirito. Eppure questo tempo dilatato questa coscienza frantumata e sull’orlo di divorziare per sempre dalla ragione e dalla realtà vengono riscattate di colpo dalla prodigiosa epifania della memoria, non quella prodotta dallo sforzo del ricordare, ma, come tutti sanno, dalla memoria involontaria quella che ha riportato l’infanzia sulla punta della lingua intinta nel tè; sempre quella che fa fermare il narratore in mezzo ad un cortile della casa dei Guermantes, perché il colore del marmo di quel medesimo cortile gli ha riportato il ricordo di un altro marmo, visto a Venezia, tanto tempo prima. E deve rimanere fermo per vincere una violenta emozione, perché il ricordo è stato pieno e forte, come se stesse accadendo adesso ed egli è felice. Banalmente e completamente felice. E se la verità non è raggiungibile con lo sforzo della ragione, essa emerge in una trama che con la logica non può essere letta, ma con altri mezzi sì.
Intendo dire che in Proust questa trama può ancora essere letta, perché le immagini del passato, che sarebbero condannate alla dissoluzione, sono trasformate in una sorta di tempo eterno dallo scrittore, dalla permanenza stessa della scrittura, quindi l’eredità del tempo che rimane o, se preferite, ritrovato, è data dall’arte e dalla bellezza della sua prosa, giustamente, più di una volta, definita simbolica [2].
Più tardi nel 1900, fu tardi. Veramente tardi. Il sentimento di una irrimediabile Sehensucht percorre la scrittura degli autori più grandi, sia per mettere sul passato una pietra tombale come fece con impeccabile bravura Joseph Roth, insegnandoci che ciò che abbiamo perduto diviene mito, pubblico o privato non importa, e ritorna solo nei sogni[3], sia per morire di nostalgia, come capitò alla poetessa russa Marina Cvetaeva, che non uscì mai veramente dalla sua camera da letto, con la carta da parati rossa a stelle d’oro, nella casa paterna in vicolo dei Tre Stagni[4].
Ma è nell’opera di Nina Berberova, nella sua prosa veloce e diretta, ben lontana da ogni sentimentalismo, che la memoria compie il suo giro definitivo su sé stessa, cancellando ogni speranza di recuperare il passato nello stabilire un filo, logico o meno, con il presente. Si tratta quindi di una memoria che potremo definire rimossa, non nel senso freudiano del termine, ma nel suo significato letterale di portata via, tolta dal suo ruolo.
Nina Berberova era pietroburghese di nascita, ma morirà a Philadelphia, ultra novantenne, nel 1993, per i drammatici postumi di una caduta. Il successo era giunto alla fine, dopo una vita avventurosa, speciale, ma anche dura, stentata, strappata agli eventi. Moglie divorziata del poeta Chodasevič, Nina insegue la stella della sua profonda libertà, lasciando la Francia, paese nel quale si era rifugiata fin dall’inizio degli anni venti, e vivendo la sua emancipazione “…come lotta individuale per una sopravvivenza sempre alle prese con l’esperienza sentimentale, l’esilio come condizione disvelante delle risorse personali e dell’infinita catena di eventi, compresi quelli più piccoli, che nascono da una rivoluzione”[5].
Capacità straordinaria la sua di vita e di scrittura, consegnata quasi esclusivamente alla lingua russa, che considerava l’argilla della creazione[6].
Di Blok noi siamo i figli, /scordare non possiamo” Che cosa non possiamo scordare? La fredda clinica dove è morta la mamma? O il quarto di pane quotidiano simile ad un mattone, pesante e umido? O la stella che nel maggio scorso c’era sopra la piazza del Senato, così verde e solitaria? Prendo quella stella, la rubo e me la porto nel sogno. [7]
Così riflette, con il cuore pieno di amarezza, la giovane Saša, protagonista della novella Pianto, rievocando gli ultimi anni passati a Pietroburgo, insieme conl’amatissima sorella Ariadna dentro a una stanza fredda e sporca, mentre il mondo diventava cenere, e il loro padre, rimasto l’unico legame con il passato borghese, scivolava dentro una quieta follia. La sua domanda è quella di una intera generazione: si deve, si può ricordare il passato, soprattutto serve a qualcosa, quando da esso ci separa una ferita profonda, incolmabile o, piuttosto, non è meglio abbandonarsi a un’onda di alta marea, che non nega dignità al ricordare, ma rinuncia a ricucire in un orizzonte di senso i tempi della vita dispersi dalla Storia? I personaggi dei racconti di Nina Berberova sono piuttosto propensi a questa seconda soluzione, conoscono l’intermittenza del cuore, ma non ne ricavano nessuna felicità, un po’ come se le immagini restituite dalla memoria rimanessero di fatto inaccessibili. Poiché la Berberova è maestra del racconto, parleremo di due brevi narrazioni, dove l’eclissi del passato annoda attorno al collo dei protagonisti il cappio, non sempre spiacevole, del presente.
Il primo di essi, prende il nome dal castello di Roquenval, dove il giovane protagonista viene invitato da un amico a trascorrere l’estate.
Dieci anni fa, nel luglio 1926, attraversai per la prima volta il massiccio ponticello di pietra con ai lati due catene arrugginite, che univa il castello di Roquenval al resto del mondo. [8]
Boris, la voce narrante, ci introduce così, quasi svagatamente, in una avita dimora dell’Ile-de-France, dove vivono i parenti del prediletto Jean-Paul. Il castello è in rovina, sintesi di un secolo, di una maniera di vivere che, in Francia come altrove, non esistono più. Sottili catene arrugginite, un giardino verde e azzurro, il portone pesante chiudono subito il lettore in un luogo metaforico, non dissimile dai castelli delle fiabe. Boris si muove in esso con tranquillità, è un ragazzo russo, bene integrato nella società francese, ma è anche uno sradicato che non sa di esserlo, protetto in questo dall’ultimo lembo dell’adolescenza e dalla condizione economica, rimasta accettabile.
Durante l’estate al castello, egli riceve molte intermittenze del cuore, mentre ascolta i tarli e la rovina delle vecchie stanze.
Uno di questi avvertimenti avviene attraverso l’incontro con Praskov’ja Dmitrievna, l’anziana nonna di Jean-Paul, venuta in Francia mezzo secolo prima per inseguire l’amore e sfuggire un fratello pressante. Le conversazioni con la vecchia dama, piene di languida e indefinita nostalgia, saranno parte dell’educazione sentimentale, che il ragazzo sta intraprendendo, costituita per l’altra metà dalla tenera attrazione per Kira, una fanciulla quindicenne, lucida e precoce e dalla pigra sensualità della matrigna di Jean-Paul, che gli ha acceso un desiderio ancora acerbo. Adesso è pronto per percorrere il viale dei tigli del parco del castello.
Guardavo il vetro opaco e mi pareva di averlo già guardato da piccolo. Lo guardavo e aspettavo che davanti a me si spalancasse la Russia che stormiva nei viali dei tigli di Roquenval ed era fuggevolmente balenata nel nome di Praskov’ja Dmitrievna, seduta sulla poltrona alle mie spalle. [9]
Il viale riporta alla sua mente turbata le estati trascorse nella casa del nonno in Russia, l’infanzia emerge dal parco di Roquenval, dai viali antichi, vivi e bui, come quelli del ricordo, nel quale gli alberi avevano una corteccia nera simile al pane di segale. Gli stipiti delle porte svelano i loro segreti, e Boris, con emozione, ritrova una scritta amorosa in caratteri cirillici, che porta la data di trent’anni prima. Ma quando l’autunno giunge, presentato come un assassino dell’estate, le cui tracce, visibili di notte, si perdono nell’ingannevole calore del giorno, anche Roquenval appare a Boris come un fantasma irraggiungibile, insieme alle sue memorie russe: “E risultava impossibile seguirlo nel suo cammino antico, romantico e senza speranza.”[10]
Accadono poi altri avvenimenti che spingono Jean-Paul e Boris a sottrarsi al richiamo perentorio del passato, come la scoperta del carattere apatico e precocemente cinico di Kira, l’aggravarsi delle condizioni della vecchia contessa, l’impossibilità di rinascere quando questa faccenda si sarebbe sistemata…[11]
Così quando il lettore è con Boris davanti al suo viale accade un’epifania, ma non è magica:
Vidi un antico viale di tigli, eternamente buio, eternamente vivo, alla cui estremità filtrava la luce del giorno, brillante e luminosa, dei vecchi alberi quasi mostruosi si ergevano davanti a me. Potevo distinguere perfettamente il gioco dei riflessi sul sentiero ricoperto di vegetazione e una pietra bianca accanto ad un grande fungo verde scuro.[12]
Il viale non è quello del castello, ma una memoria suggerita dai libri dei classici russi, che, in un gioco di vedo non vedo, hanno già fatto capire al ragazzo che la patria perduta è dentro di lui, è vero, ma perduta per sempre. Boris è un giovane sensibile e attento, ma è, prima di tutto, un personaggio novecentesco: non ha innocenza, né vere speranze. La vocazione di riconoscere, ridestare moventi, affetti e ricordi, non è per lui inconsapevole e illuminante e ricordare non serve a fargli credere di più nella razionalità della sua storia e di quella degli altri.
La scoperta improvvisa e struggente è molto diversa, e appare a Boris dopo l’ultima notte che trascorre al castello, ormai solo con un vecchio maggiordomo:
… era volato via lo spirito ormai solo a me caro, di queste vecchie vestigia che non mi appartenevano. Le impressioni si erano dissolte, le immagini avevano assunto una sfumatura irreale… un silenzio triste e disperato avvolse subito quanto stavo lasciando: le nostre stanze, i saloni con la fodera, la scala. Nel monotono sussurro dell’autunno anche il parco si fece silenzioso; il portone sbatté per un’ultima volta e si zittì, cigolò la chiave e dietro a me il mio viale ammutolì: in quel mattino sembrava il monumento ad un mondo che da tempo non esisteva più né qui, né nel mio paese, né in nessun altro luogo.[13]
La memoria è venuta, ha illuminato il lunare paesaggio del passato, ma ha restituito poco o niente, e quel poco sembra così inutile, rispetto alla ferita radicale e irrimediabile che taglia in due la nostra vita, quel passato giace da qualche parte dentro la nostra anima e, nello stesso tempo, è separato da noi per sempre.
Qui la seconda parte dell’articolo.
[1] L. de Robert, Comment débuta Marcel Proust, Parigi, Gallimard, 1969.
[2] W. Benjamin, Per un ritratto di Proust, in: Avanguardia e rivoluzione. Saggi sulla letteratura, Torino, Einaudi, 1973 (nel saggio sono contenute riflessioni illuminanti proprio sul rapporto tra il tempo e l’eternità).
[3] Per tutta l’opera di Roth, la disperazione, la perdita, si veda la biografia del suo migliore amico, lo scrittore Soma Morgenstern. Nel saggio, risulta chiaro, e i curatori ne danno conferma, che l’unico sopravvissuto alla diaspora del tempo è l’autore stesso, quando è vivo materialmente o attraverso la memoria dei posteri. Soma Morgenstern, Fuga e fine di Joseph Roth, traduzione di Sabina de Waal, cura di Ingolf Schulte, Milano, Adelphi, 2001.
[4] Il ricordo della sua stanza di giovane ragazza accompagna come un fantasma soffocante la poetessa, e ne sottolinea l’emarginazione, si legga, a questo proposito, la stessa Marina, in: M. Cvetaeva, Una parola viva su un uomo vivo, in: Incontri, traduzione e cura di Mariolina Doria De Zuliani, Milano, La Tartaruga, 1993, p.53 e segg.
[5] Lidia Campagnano, 1993, Il 900 dell’accompagnatrice, “Il Manifesto”, 28 settembre.
[6] Vittorio Strada, 1993, La lingua argilla della mia vita, “Corriere della sera”, 28 settembre. L’articolo ricorda che in russo Nina scrisse tutto, fuorché una monografia su Aleksandr Blok, scritta in francese. Lo studioso, escludendo un attacco romantico della scrittrice al proprio idioma, riporta asciuttamente, le sue motivazioni: “Una persona, che per tutta la vita fa sculture d’argilla, d’un tratto si sente domandare perché non lavora con il metallo. Così stanno le cose con me: la lingua russa per me è l’argilla per l’intera vita.
[7] Nina Berberova, Pianto in: Alleviare la sorte, trad.it di Bruno Osimo, Milano, Feltrinelli, 1988, p.95.
[8] Nina Berberova, Roquenval. Cronaca di un castello, traduzione italiana di Gabriele Mazzitelli, Parma, Guanda, 1992, p.9.
[9] Nina Berberova, Roquenval. Cronaca di un castello, op. cit., p. 23.
[10] Nina Berberova, Roquenval. Cronaca di un castello, op. cit., p. 57.
[11] Nina Berberova, Roquenval. Cronaca di un castello, op. cit., p. 38.
[12] Nina Berberova, Roquenval. Cronaca di un castello, op. cit., p. 11.
[13] Nina Berberova, Roquenval. Cronaca di un castello, op. cit, p. 77.