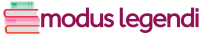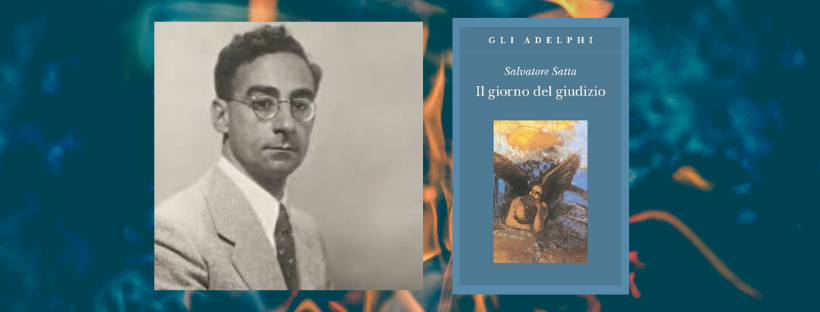Grande interprete e testimone della condizione umana e delle sue continue contraddizioni, Salvatore Satta, scrittore sardo, di Nuoro, per l’esattezza, e prima ancora che autore, giurista, dovrebbe essere accolto a pieno titolo nel canone della letteratura italiana del novecento.
Nato nell’agosto del 1902 nella Barbagia, Satta cresce in un luogo oscuro, di padroni e di servi, fatto di riti antichi, un «nido di corvi» dove figurano pastori, che «rappresentano la vita dinamica, e contadini che rappresentano quella statica».
Cultore della scienza del diritto, e per questo conosciuto nell’ambiente giuridico, cattolico e favorevole alla pena di morte, è divenuto illustre grazie però a un romanzo che iniziò a scrivere nel 1970 e che terminò (anche se fondamentalmente l’opera resta incompiuta) cinque anni dopo, quando morì a causa di un tumore al cervello. Si tratta de Il giorno del giudizio che fu pubblicato nel 1977 dalla casa editrice Cedam e che passò in sordina. Nessun recensore accostò il suo nome all’opera. Il testo, grazie all’insistenza dell’amico Francesco Mercadante, che racconta come quello “fu un libro rifiutato dall’intero mondo editoriale. Poi finalmente un editore di testi giuridici, Cedam, lo pubblicò. Ricordo la gioia del mio amico Enrico Opocher che parlò in proposito di un nuovo Gattopardo. Modestamente contribuii a che Adelphi riscoprisse questo autore che proveniva da un mondo altro”, fu appunto ripubblicato dalla casa editrice Adelphi nel 1979, ottenendo un grande successo e la traduzione in diciassette lingue.
Accadde poi che nel 1987 George Steiner sul New Yorker scrivesse «Nessuno scrittore della memoria, a parte Walter Benjamin, comunica in modo più toccante di Salvatore Satta (si noti il presagio contenuto nel suo nome di battesimo) il diritto degli sconfitti, dei ridicoli e degli apparentemente insignificanti a essere dettagliatamente rievocati […] La composizione del testo, allo stesso tempo episodica e fittamente intrecciata al proprio interno, richiama alla lontana quella dell’Antologia di Spoon River, ci sono momenti di vivace satira sociale, voci pompose o tumultuose come quelle che si odono in Sotto il bosco di latte. Ma né Edgar Lee Masters né Dylan Thomas hanno l’intelligenza filosofica, la pazienza della sensibilità che consentono a Satta di realizzare una struttura formale pressoché priva di difetti. Migliore analogia la troviamo nei pittori. Gli effetti raggiunti ne Il Giorno del giudizio possiedono la misteriosa autorità che vive nella grana delle cose in uno Chardin, l’opaca luminosità che ci arriva dai corpi umani di La Tour … Solo nei Morti di Joyce risuona in maniera tanto commovente il passo del tempo che mai più tornerà».
Una vera e propria ammissione di grandezza nei confronti di Salvatore Satta che viene così riscoperto ancora una volta anche in Italia. Nuoro, la sua città natale e luogo in cui è ambientato il romanzo stesso, che inizialmente aveva accolto con diffidenza il libro, è costretta a rendere omaggio alla penna dello scrittore e alla sua opera. L’artista nuorese ha scritto il libro su dei foglietti sparsi, e su alcune agende, con una calligrafia minuta e quasi sempre con dell’inchiostro azzurro. Il romanzo è stato messo giù interamente a mano e solo in seguito battuto a macchina. Parliamo di 369 facciate per due agende, datate 1971 e 1972, con copertine di pelle chiara, che rimasero custodite in casa di Satta. Il dattiloscritto, invece, sembrava essere stato perduto per essere poi ritrovato per puro caso in un fascicolo dell’archivio legale.
Nulla è più eterno a Nuoro, nulla è più effimero della morte. Quando muore qualcuno è come se muoia tutto il paese […] e veramente l’ala della morte posa sulle casette basse, sui rari e recenti palazzi.
Si segue così la storia di una famiglia, i Sanna Carboni, notai rispettabili, e di Nuoro, luogo elettivo della scena letteraria, in una Sardegna che è «isola di demoniaca tristezza». Ciò che aleggia ovunque è la morte. Vivi e morti, dunque, legge e ingiustizia, sono questi i poli opposti che con forza si contendono le pagine del romanzo.
Gli echi di un passato che sembra lontanissimo e che invece è dietro l’angolo, dove «la notte è eterna e effimera non solo per gli uomini ma anche per le cose», fa da sfondo ad altre vite, in altre solitudini e attese mortifere.
Donna Vincenza, moglie e madre, stava in un angolo, avvolta nei suoi panni neri, come si conveniva ai suoi cinquant’anni, esausta, ingrassata dalle maternità, il capo sempre chino sul petto. Ciascuno di quei figli era ancora come dentro le sue viscere, e nel suo silenzio ascoltava le loro voci come i moti segreti e misteriosi di quando erano nel suo seno.
Una narrazione essenziale, dove ogni parola trova la sua corrispondenza, mantenendo un equilibrio sottilissimo e, al contempo, poderoso.
Nella notte profonda, Nuoro si stendeva percorsa da un vento gelido. Rotolava lontano un carro sul selciato. Non una voce. Due carabinieri in pattuglia, rigidi e annoiati, venivano su per il corso. Faceva quasi paura […] i nuoresi sono personaggi da tragedia.
L’intento iniziale di Salvatore Satta era quello di condurre una vera e propria indagine su ciò che fu del suo paese, del suo vissuto e delle rimembranze di chi abitava i luoghi. Più si va avanti nella lettura e più l’autobiografismo viene trasfigurato in una visione quasi demonica. Una Sardegna arcaica e moderna al tempo stesso, ridestata nel suo senso d’angoscia, è ciò che accomuna tutte le storie e i personaggi di una narrazione che è memoir, saggio, indagine archetipica. La finitudine pervade ogni capitolo e diventa presenza costante e ossessiva.
In un carteggio tra Satta e l’amico Bernardo Albanese, emerge il trauma per la morte del fratello Filippo, che avvenne nel 1969. «Oggi che Dio è incerto, scompare anche l’idea del castigo e noi restiamo in preda a noi stessi». Filippo lasciò in eredità la casa di famiglia a un istituto religioso e questo segnò il taglio del cordone ombelicale di Salvatore Satta con la sua isola natia. Il giorno del giudizio è stato il suo modo di impedire il dissolvimento di un cosmo personale, la sua maniera di mantenere in vita un pezzo di quello che era stato, con una speranza d’eterno. Lo scrittore sardo, perennemente assalito da molti dubbi sulle sue abilità di romanziere, scrive ancora all’amico Bernardo «E vivo nella paura di essere come i buoi, di cui si dice che abbiano gli occhi che ingrandiscono le cose che vedono. Forse tutto quel che faccio è una sciocchezza».
In questo romanzo, che è tutto memoria o ha a che fare con essa, Salvatore Satta compie il prodigio della tangibilità della rimembranza. La memoria diventa oggetto percepibile da chiunque.
Scrivo queste pagine che nessuno leggerà perché spero di avere tanta lucidità da distruggerle prima della mia morte nella loggetta della casa che mi sono costruito nei lunghi anni della mia laboriosa esistenza. È un’alba di fine agosto, un’ora in cui l’estate ancora piena cede alla passione dell’autunno. Fra poche ore tutto sarà diverso, ma intanto io vivo questo annuncio di una stagione che è propriamente la mia.
(Il giorno del giudizio, 1979)
Tuttavia, il rapporto tra Satta e il popolo sardo è voragine che scava dentro di lui fino a renderlo a tratti estraneo alle vicende natie, a tratti un tutt’uno con esse – scrive nel libro Spirito religioso dei Sardi edito da il Ponte nel 1951:
Molte volte, pensando ai Sardi, pensando a me stesso, mi sono chiesto se noi crediamo veramente in Dio. È una domanda alla quale è difficile rispondere, perché bisognerebbe prima intendersi sull’idea di Dio. Certo, il Dio “che atterra e suscita” sembra lontano da noi, né il principio del bene raggiunge per noi tanta assolutezza da non ammettere, quasi in un’eco di eresia, il principio del male. D’altra parte, chi ha il senso così vivo e così agitante della legge e del peccato (il senso della morte, si può dire brevemente, perché nessuno come il Sardo sa che deve morire) ha qualcosa più della fede, ha una vocazione di santità: assurda, anacronistica vocazione, che ci vieta di inserirci nel processo della storia, e ci porta fatalmente a risolvere la storia nell’utopia. Forse, come i nostri padri, sotto la spinta dei pirati e della malaria, fuggirono le coste, e si costruirono sulle alture le loro capanne, i villaggi di oggi, così noi, aggrappati alla nostra utopia, in una luce di crepuscolo, fuggiamo quasi d’istinto il torbido mare della vita.
Non si può comprendere a fondo il Satta scrittore senza fermarsi a riflettere sul ruolo che ha avuto da giurista, un ruolo di primissimo ordine e che ha influenzato, non poco, la stesura del suo romanzo.
Il giorno del giudizio è altresì un trattato filosofico-esistenziale, una domanda su Dio, sulla sua esistenza e sulla morte; quest’ultima avvolge ogni cosa pulsando sui volti e facendosi movimento nei protagonisti.
Sono stato una volta piccolo anch’io, e il ricordo mi assale di quando seguivo il turbinare dei fiocchi col naso schiacciato contro la finestra. C’erano tutti allora, nella stanza ravvivata dal caminetto, ed eravamo felici poiché non ci conoscevamo. Per conoscersi bisogna svolgere la propria vita fino in fondo, fino al momento in cui si cala nella fossa. E anche allora bisogna che ci sia uno che ti raccolga, ti risusciti, ti racconti a te stesso e agli altri come in un giudizio finale. È quello che ho fatto io in questi anni, che vorrei non aver fatto e continuerò a fare perché ormai non si tratta dell’altrui destino ma del mio.
(Il giorno del giudizio, 1979)
Il destino dell’uomo come destino di un popolo, è il termine ultimo di un logorio ai limiti dell’umano e un’evidenza incoercibile a cui Satta dedicò il suo libro più vero.